S’è detto più volte che il Perceval di Eric Rohmer mantiene una fedeltà al testo chrestieniano. Ciò è pur vero da molteplici punti di vista. Innanzi tutto, è noto, Rohmer ha optato per un mantenimento quanto più fedele possibile al dettato testuale, nei dialoghi e nella diegesi del romanzo. Il regista ha optato per una trasposizione del testo del narratore medievale in un francese ammodernato ma che mantiene il sentore dell’antico, rispettando il couplet di octosyllabes a rima baciata proprio del testo di partenza e lasciando, nei limiti quanto possibile alla comprensione dello spettatore moderno, il lessico originario o comunque un lessico dalla patina arcaicizzante, Rifiuta cioè Rohmer una trasposizione del testo letterario di partenza secondo un dialogato e il registro della parlata moderna, Non solo, ma pure, è cosa nota anche questa, non solo nel film sono riportate le parole dei dialoghi dei diversi personaggi, ma viene inoltre riportata la parte più specificamente narrativa, diegetica e descrittiva del testo: questa è affidata in genere al coro o a personaggi secondari, oppure a una voce fuori campo, o, ancora, ai personaggi stessi, quando è di essi che si parla, i quali, lasciata la prima persona verbale, parlano di sé in terza persona. Ne risulta un effetto di straniamento abbastanza ampio, magari urtante nei confronti dello spettatore medio, il quale si aspetterebbe un parlare, un dire e un dialogare più conforme a ciò che è per lui il parlare ‘naturale’: ne resta quindi esaltato il valore e l’effetto di letterarietà del testo cinematografico e il suo riferirsi alla letteratura: ciò che esalta il significato e la valenza di riscrittura, di testo riscritto, forse ancor più che non l’effetto di una traslazione in cinematografico di una pièce teatrale prossima al teatro medievale e alla rappresentazione dei Misteri. L’operazione è dunque quella di rappresentare la letterarietà medesima, di far concentrare l’attenzione dello spettatore proprio sullo scarto che esiste tra il linguaggio cinematografico più atteso e convenuto e una letterarietà ormai assai distante nel tempo, in quanto ciò che si vuole rappresentare non è soltanto la storia di Perceval e il significato che essa contiene e che viene sottoposto all’interpretazione tanto del regista in primo luogo, quanto dei fruitori; ciò che si vuole rappresentare è anche il medioevo stesso e i modi di fruizione di esso da parte dei contemporanei suoi, e dunque anche lo scarto che lo separa dalla contemporaneità. E gli elementi strategici che marcano una tale distanza, e portano il testo fuori da un realismo moderno sono costituiti, fra l’altro, dal ritmo cantilenante indotto dal verso e dalla rima baciata; il tono alquanto declamatorio, pur variato nelle diverse sfumature di tonalità che assecondano i diversi stati emozionali dei personaggi o i loro caratteri; ed ancora la diversa disposizione emotiva della voce narrante affidata, come s’è visto, al coro per lo più, ma anche ai personaggi medesimi in terza persona, e che pure dà luogo a un dire comprensibile agli spettatori moderni, data la trasposizione in un francese attualizzato. E tutto ciò fors’anche con una accentuazione e un sovradimensionamento della reale portata tonale del testo chrestieniano; il quale, pur magari potendolo e volendolo far rimanere entro la particolare trasposizione linguistica, antichizzante, operata da Rohmer e dai suoi collaboratori, avrebbe potuto anche prendere tonalità recitative diverse e più piane, tali che assorbissero il ritmo e la rima in una recitazione più disciolta e dissimulante. Dato, questo, che, a mio avviso, riafferma il carattere ‘teatrale’ di questa performance cinematografica e la volontà di riproduzione, reinterpretata ben ovviamente, di una ambientazione e di una semiotica medievale; ne risulta insomma accentuato il senso, se mi è permesso dirlo, antirealistico poetico (in senso ampio), e metafisico della narrazione; ne risulta esaltata e accentuata e messa in rilievo la recitazione medesima, la rappresentazione come fatto recitativo primariamente, e dunque la riscrittura e il suo processo; la recitazione come fatto costitutivo primario del significato, e come tale esibito. Via primaria per marcare la distanza temporale che separa il dodicesimo secolo dal ventesimo, ma, allo stesso tempo, per permetterne anche nella e alla modernità una ricezione fruibile, anche se a costo di un certo sforzo. Un compromesso, lo dico nel senso più nobile del termine, riuscito.
Anche sulla scenografia molto si è detto e lo stesso Rohmer lo ha rimarcato in alcune interviste. S’è detto che essa ha un aspetto duplice, in parte realistico, in parte volutamente finto e anche qui tendente al metafisico e all’astrazione simbolica. Da un lato sono realistici gli abbigliamenti, le vesti, i costumi, le armi, gli oggetti, i cavalli, le acconciature, gli strumenti musicali, le vivande che stanno sulla scena o addosso agli attori e che contribuiscono ad attribuire un senso di ‘vero’ alla parola peraltro straniata per la via e nei modi che abbiamo già detto e visto. D’altro canto però gli ambienti sono palesemente e volutamente finti, smaccatamente esibiti come, anche qui, teatrali, e di un teatro che, inoltre si esibisce come tale, accentuando i suoi propri tratti di messa in scena. E l’intero film è stato girato in interno, anche laddove, e non è poco, la scena narrativa è ambientata all’esterno: la foresta, la landa, il paesaggio fluviale, il campo innevato, l’accampamento militare. L’idea immediatamente percettibile è quella di una scena di cartapesta. Anche riguardo a ciò Rohmer ci ha dato delle indicazioni di lettura e delle sue intenzioni. Riprendere e proporre allo spettatore un reale paesaggio o elemento naturale-paesaggistico, quale che esso sia, un albero per esempio, avrebbe significato sovrapporre la nostra odierna visione di quest’albero o di tal fiume o prateria, alla visione che ne poteva avere il medioevo, o comunque alla resa testuale che il medioevo ne poteva o voleva o sapeva fare, una resa che appunto non è mai realistica, ma semmai evocativa o simbolica, schizzata e suggerita più che descritta; mentre sono più particolareggiate le descrizioni fisionomiche, dei volti primariamente, ma poi pure degli interni, delle vesti, delle armi, degli arredi e delle suppellettili. Anche qui dunque un fatto di fedeltà al testo originario dunque, da intendersi non tanto come riproposizione di quanto esso dice, quanto come percezione che il lettore medievale ne aveva. Ma anche stavolta, come è stato per ciò che concerne la parola, questa azione di recupero di una percezione di un tempo non più nostro, è volutamente sottolineata, e in qualche modo diventa protagonista, o coprotagonista, della rappresentazione filmica. È l’operazione stessa di recupero che viene dunque proposta, fra le altre cose, una sorta di perlocuzione a risalire indietro non tanto nel tempo e nei dati e contenuti (ideali e concettuali) del tempo, quanto nella sua forma.
E allora ecco castelli di cartapesta, che suggeriscono una forma più che riprodurla, poco più alti delle persone stesse, dai colori irreali e inverosimili, ecco le lande e le foreste senza reale profondità spaziale e il cui orizzonte pare essere un invisibile fondale, più o meno un nulla, a sostenere la valenza tutta interiore della storia narrata; ecco i famosi, noti e famigerati alberi stilizzati, in metallo, che rasentano certe forme dell’arte d’avanguardia del XX secolo: quei, qualcuno ha detto, quei cavoletti di Bruxelles rovesciati su delle aste che fungono da tronco, più bassi del cavaliere Perceval, perché nel romanzo cortese la foresta è una dimensione non un paesaggio; ecco la barca del Re Pescatore, anch’essa così palesemente finta, quasi fuoriuscita da una illustrazione di un libro di favole d’antan, e che parla più all’immaginario fantastico, che non alla filologia ricostruttiva, o forse parla a una filologia e con una filologia testuale e non storicistica, che veda nel castello del Re Pescatore e in tutto ciò che lo circonda, lo spazio di un non luogo, che dal nulla sorge e nel nulla torna, ma di cui resta la traccia, come una realtà che sia stata deformata, o sia nata da questa stessa deformazione. Ed ancora Perceval che si innalza su un poggio, perché questo è stato detto essere, ma che è un rialzo da scena appena connotato da pochi tocchi che ne suggeriscono la natura montana, poggio dal quale Perceval scruta l’invisibile castello del Graal. Ed ancora la piana innevata su cui cadono le gocce di sangue dell’oca ferita e che provocano la rêverie di Perceval perso nel ricordo della bella Blanchefleur, la quale appare, nella scena filmica, per qualche attimo attraverso un’apparizione del suo volto che si sovrappone alla scena: e l’innevamento è dato attraverso una illuminazione biancheggiante del solito paesaggio con gli alberi-cavoletti, quasi fosse protagonista il paesaggio il quale gira intorno al protagonista, e nel protagonista, e non viceversa.
È stato pure detto che lo spostamento da una scena all’altra per lo più non avviene, in questo film rohmeriano, per stacchi scenici o per dissolvenze, ma avviene, quasi paradossalmente e antifrasticamente, tramite un continuum spaziotemporale in cui la cinepresa non abbandona praticamente mai o quasi mai il protagonista, e lo segue in un movimento, anche referenzialmente parlando, immoto e circolare, che sottolinea più le diverse disposizioni di una soggettività che si costruisce progressivamente: e progressivamente ritornando su di sé. Lo spazio esteriore è dunque, si potrebbe dire, contratto, pur non abolito. Da un lato esso è dispiegato come una serialità di luoghi e di stati, dall’altro è il filo ininterrotto che tiene uniti questi ultimi nel puro andare del valletto gallese: bella significazione iconico scenica dell’erranza cavalleresca, dato primario del romanzo cavalleresco, concetto rappresentato nella sua concretezza straniata, e sottolineatamente insistita.
Ma torniamo al testo e lasciamo la scenografia. S’è sempre parlato di fedeltà al testo chrestieniano di partenza da parte di Rohmer. E certo questo è vero se intendiamo dire che il testo è stato rispettato nella sua essenza linguistica, poetica e metrica, quasi una trasposizione appunto in un francese appena ammodernato per il minimo sufficiente alla comprensione odierna. S’è già detto appunto. Ma la storia, gli episodi, non sono sempre totalmente rispettati, anzi mi pare che Rohmer alteri, anche profondamente il significato del romanzo di Chrétien de Troyes. E in un certo senso attribuisce un finale tutto suo a questo romanzo medievale rimasto, come è noto, non finito e non concluso: con un finale lasciato aperto, qualunque ne sia stata la causa, a soluzioni esterne ed altre. Rohmer insomma l’ultimo dei continuatori del romanzo percevaliano del Graal, potremmo dire. Non solo il testo ha subito dei tagli, cosa che era ovviamente inevitabile per restare nei limiti del tempo di un film, ma alcuni tagli o agglutinazioni sono significativi e sottraggono alla rappresentazione della vicenda punti in cui tale significato viene a concentrarsi e a coagularsi. Per esempio troppo sbrigativamente è liquidata la figura della madre del protagonista: soprattutto manca al film la scena in cui, nel romanzo, Perceval dice di voler oltrepassare il fiume al di là del quale egli è certo troverà la madre, ma il fiume non viene oltrepassato e Perceval incontrerà l’avventura del Re Pescatore e del Graal, un modo, certo tutto indiretto di ritrovare sua madre, o meglio la sua significativa assenza che si renderà poi nuovamente presente come desiderio e nella colpa. Una tale posizione sembra esprimerla poi lo stesso Rohmer quando dice che il desiderio della madre andava negato affinché Perceval potesse compiere la propria avventura: cosa vera soltanto fino a metà: si trattava infatti di abolire la madre come realtà per suscitarla appunto come desiderio, il cui simbolo Perceval non riesce a riconoscere nel Graal, mentre si trova a contatto con il filo matrilineare del suo lignaggio. Né ci è rappresentata la divinazione, da parte dell’eroe del proprio nome, conseguenza immediata e fulminante della acquisizione della coscienza nel momento in cui gli è rivelata la propria responsabilità (la morte della madre da lui stesso causata nel momento dell’abbandono) prima ancora del senso della colpa, che egli acquisirà più tardi nel colloquio confessione con lo zio eremita (pechez la boche te trancha, quando ha taciuto davanti al Graal in quanto ha obliterato e cancellato in sé il linguaggio interiore materno). Anzi questa prima rivelazione, la divinazione del suo nome, è innescata dalla cugina (materna) del protagonista cui è stato ucciso il suo uomo, il cui cadavere è presso di sé, ed ella rimprovera a Perceval il suo silenzio; la cosa gli sarà poi rinfacciata con accusa e improperio dalla demoiselle hideuse, dopo che Perceval sarà perfettamente integrato nella corte arturiana. Nel film rohmeriano invece i due personaggi femminili sono praticamente fusi in uno solo: in pratica nella damoiselle hideuse, dipinta filmicamente nel suo orrore laido; tale personaggio occupa tuttavia, nella sequenza narrativa, il posto della cugina di Perceval, così che viene a mancare l’accusa buttata in faccia a Perceval in piena corte, accusa che dal personaggio ricade sulla corte stessa: sulla cavalleria mondana, o meglio su un’idea di cavalleria come fino ad allora era stata concepita e condotta e che aveva provocato il rifiuto, il dolore e la morte della madre del nostro eroe. Ancora: l’avventura di Gauvain è dimezzata, manca tutta la seconda parte e soprattutto quella della prigionia di Perceval, il ricadere di lui, l’eterno dongiovanni, nella prigione femminile, nel castello delle madri: manca insomma il parallelismo inverso dei due eroi, Perceval e Gauvain: di un Perceval che si costruisce abbandonando la madre reale, ma ricostruendola simbolicamente, e di Gauvain che, in una sorta di roman à tiroirs, di avventura in avventura, di gonnella in gonnella, finisce per decostruire se stesso, prigioniero delle madri e delle gonnelle. Tutta la seconda parte della avventura di Gauvain è da Chrétien narrata dopo l’episodio dell’incontro e della confessione di Perceval con lo zio eremita. Nel film a quest’episodio segue la rappresentazione della passione di Cristo e l’identificazione di Perceval con il Cristo stesso, sofferente e morente: in pratica l’interprete si Cristo è lo stesso Fabrice Luchini, cui è stata aggiunta la barbas. Invenzione tutta di Eric Rohmer, questa; e del tutto assente in Chrétien. Ma attenzione: tutta questa scena che riproduce il Venerdì Santo è proposta anche qui come una sacra rappresentazione che fuoriesce dalla lettura del testo evangelico operata da chierici, quasi gli attori e l’azione fossero un prolungamento della loro parola: una rappresentazione al quadrato, insomma, in cui è la parola a generare l’azione: il che è la cifra di tutta questa nostra rilettura
Una soluzione e interpretazione mistica, comunque, quella che dà il nostro contemporaneo regista alla non conclusione del romanzo di Chrétien de Troyes. Conclusione che si può quanto meno dubitare fosse nelle intenzioni e nella mente di Chrétien, e forse la conclusione dell’autore medievale era quella, piace almeno ipotizzare e fantasticare, di un finale aperto, almeno a livello diegetico, ma concluso nella specularità asimmetrica dei due eroi, e delle due idee inverse di cavalleria che essi incarnano.
È un voluto svisamento di Chrétien quello di Rohmer? Solo una lettura e un’interpretazione sua personale, un’idea soltanto mistica quella del medioevo rohmeriano? Tutta la mise en scène, che abbiamo visto e come la abbiamo vista, di un mondo narrato (e filmato), fra favola e metafisica, parrebbe teso a indirizzare lo spettatore verso una fuoriuscita dal mondo concreto e reale, che del reale non ha più le coordinate. Un mondo che nel nostro narratore medievale è, certo, fatto invece pure di psicologia e di costruzione del sé, di cui la conquista della dimensione spirituale è l’ultimo culminante gradino. La regia rohmeriana (con la ‘sua’ sceneggiatura e la sua scenografia) straniata-straniante, e la sua rilettura che giunge a tal finale, sembrano così condurci alla conclusione che Perceval si muova e agisca non in una dimensione psicologico-pedagogico-soggettiva: ma in una alterità assoluta. Ed è il medioevo stesso tale alterità. Questo finale ci porta insomma verso la fuoriuscita dal sé, facendo in parte rientrare i continuatori di Chrétien, e la dimensione mistica del Graal, nel testo di lui. Come dire che Chrétien è anche i suoi continuatori, è anche il mondo letterario, ideale e ideologico, che comunque, bon gré mal gré, da lui è stato suscitato e che a partire da lui ha preso corpo. Perché un testo è anche la sua ricezione. E quella del nostro Eric ne è, pur indotta, una variazione possibile.
Et notre film sans nul arrêt Va chevauchant par la forêt. Nella selva delle interpretazioni Maurizio VIRDIS

 Articoli del blog
Articoli del blog 




































































































































































































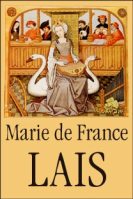























 Sa pratzidura diatòpica de sa lìngua sarda/La divisione diatopica della lìngua sarda
Sa pratzidura diatòpica de sa lìngua sarda/La divisione diatopica della lìngua sarda











.jpg)










