Lelettere iTesti IcOmMeNtI
meta mvirdis

Contatti: info@mauriziovirdis.com virdis@unica.it
Tel. +39 0706757221, Fax: +39 0706757289
__________________________________________________________________________________________
Alessandro del Prato: Allegoria della Verità – 1965 (Elaborazione) – Mantova Palazzo Te

ahh…! mon ennuy dans cette nuit de lachmann «logico il filo?» mi disse; e prostrato: espungere – sostituire ? raccogliere ora frammenti: dannato cimento; comporre interpunta l’imago perduta: è il solo gioco. Diffratto miraggio, usata alternanza, consunta variatio. Emendare alterato sussulto ch’empie un presunto spazio da tempo mancante: rumore: scrivere in calce parola preclusa abusata: mancata, nel corpo sul filo è portata, censita, testata da prova di stilo – chissà, raccattata o profonda! difficile letta comunque: giusto in tempo di trovare, là, là, …,…sì… eeeh eh…ecco !!! ci va! E allora? riprovaci ancora: riscrivi da capo. Capisci? – Such stuff as dreams are made on.
Vai s’en lo tems, e perdem lo melhor !
Parlar degram ab cubertz entresens,
E, pus no·ns val arditz, valgues nos gens !
(Bernart de Ventadorn, Can l’erba fresh v. 46)

Quid autem te amisso sperandum mihi superest? O si fas sit dici crudelem mihi per omnia Deum! O inclementem clementiam!
______________________________________________________

_______________________________________________________________________
Maurizio Virdis non disdegna scrivere versi in metro più o meno regolare:
Ammeriai in meledu isciortu
próbiu unu muru scallentau d’ortu
ascurtai mein s’orrù e me’ is scrarías
tzoccu ’e meurras, frúsiu ’e tzrepías.
Me’ is crebadas ’e sa terra e in sa faiccedha
sminciai arrúbias is rias de frommigas
ch’immoi si segant e immoi si trobedhant
me’ is cuccuredhus pitticcus de is bigas.
E pramizai diattesu intra de is mattas
su mari assuppendi in iscattas
mentris si pesant tzirrícchius tremuaus
de cixa ’e is cuccurus scuccaus.
E in s’alluinu ’e su soli chi scalla’
attuai cun trista meravilla
comment’esti sa vida su traballu
de andai arreu ororu ’e una muralla
spraxa in pitzu de bícculus d’ampulla.
Tanto gentile…
Tantu gentili e onesta è’ a s’avverai
sa donna mia cand’átteru saluda’
ch’ogni lingua tremendi torrat muda
e s’ogu no s’attrivi’ a dha castiai.
Issa si ’nci anda’ a s’intendi alabai
beninna ’estida d’umilesa in muda
e cosa bénnia parit, chene duda,
de celu innoi miraculu a sciorai.
Chini dha mira’ aicci si ’ndi prexa’
chi ’e is ogus recci’ in coru unu durciori
chi scî no podit chini no dhu proat,
e de is laus suus parit chi ’ndi moat
un’ispíritu léviu prenu ’e amori
chi andat narendi a s’ánima ‘susprexa!’.
***
G. CAVALCANTI Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira – sonetto
 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, che fa tremar di chiaritate l’âre e mena seco Amor, sì che parlare null’omo pote, ma ciascun sospira? O Deo, che sembra quando li occhi gira, dical’ Amor, ch’i’ nol savria contare: contanto d’umiltà donna mi pare, ch’ogn’altra ver’ di lei i’ la chiam’ ira. Non si poria contar la sua piagenza, ch’a le’ s’inchin’ ogni gentil vertute, e la beltate per sua dea la mostra. Non fu sì alta già la mente nostra e non si pose ‘n noi tanta salute, che propiamente n’aviàn conoscenza.
Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, che fa tremar di chiaritate l’âre e mena seco Amor, sì che parlare null’omo pote, ma ciascun sospira? O Deo, che sembra quando li occhi gira, dical’ Amor, ch’i’ nol savria contare: contanto d’umiltà donna mi pare, ch’ogn’altra ver’ di lei i’ la chiam’ ira. Non si poria contar la sua piagenza, ch’a le’ s’inchin’ ogni gentil vertute, e la beltate per sua dea la mostra. Non fu sì alta già la mente nostra e non si pose ‘n noi tanta salute, che propiamente n’aviàn conoscenza.
***
Chin’est custa chi bêit tottus prexendu
chi de lugori s’àiri a tremî fai’
e Amori porta in fattu chi fuedhai
niscxiunu poit, ma ognunu est susprexendu? 
’Ta parit, Deus, is ogus furrïendu,
dhu neri’ amori, ch’eu no dhu scia contai:
tantu ’e umilesa parit donna, giai,
chi dogn’attra a facc’issa m’est duendu.
No s’iat podi contai su praxi ’e custa
c’a issa incrua gentili ogna virtudi,
e s’ermosura che dea sua dh’ammostra.
Aicci’ arta no fiat mai sa menti nostra,
tantu saludu in nos mai postu fudi
chi ’ndi tengiaus sa conoscèntzia giusta.
__________________________________________________
Galleggiare pallido e assorto
dentro la vita col muso storto,
indovinare, se non ti scerpi,
voci intraviste tra siepi e sterpi.
La visione appannata d’una breccia
empie il tuo ventre d’immagini antiche
che si sfilacciano dentro il pensiero
che scivola per erte lubriche.
Rimuginare tra i rami il brancicare
che s’avviluppa tra smanie amare,
mentre s’involano d’aspri crocicchi
le vane ciance d’anime a spicchi.
Poi incespicando nell’avvisaglia
realizzare, nell’intima guerriglia,
come tutto soltanto sia il travaglio
d’interpellare ciò che ti sbaraglia
introverso fra sbarre di bastiglia.
[L’ombra d’Eugenio]
__________________________________________________________________

___________
 Soror dulcissima, mente te diligo,
Soror dulcissima, mente te diligo,
ablato corpore. Ignosce, deprecor,
mihi insaniam, pupilla oculi
qua ego video, venusta formula.
Secretum animae solvere cupio
tuae, pulcherrima: quod solvat somnia
cogitationibus iam vero sordidis,
fictionis nebulis dum mecum maneo.
Commotus corporis tui cupidine,
nudum cospiciens mirum mirabile
fictum quod teneo intus intrinsecus,
nudam te amavero, corde purissimo:
cum esses veritas nudata ad animum,
nolo te tangere, ne tuum mysterium
totum se dissipet in nihili vacuo,
nisi ab oculis tactum me sentiam
tuis, si subrideas, qui sunt caerulei:
tanta tua gratia.
Tua tanta gratia laudetur Dominus qui tecum maneat, in veri lumune:
Eius es speculum.
___________________________________________________________
Entremesdames
Perfetto cerco amor non discrepante,
 anima che t’assilli nel saperti:
anima che t’assilli nel saperti:
qual Eliduc, prossimo alla follia,
poté comporre in sé fantasma e senno
in discordo, tal io possa vagliare,
zarandeando fra immagine e vita,
il simbolo d’amore, irriducibile,
da sottrarre alla rena del non detto.
Norma d’amor lontano cerco stabile,
ostinata al variar della cagione,
rimestandovi il corpo e la ragione,
misurandone il dato col probabile
aggiunto d’inconclusa verità.
D’altro intelletto, mio soltanto, giunga
amorevole fiamma, per cui funga
mon bon respeig specchio di carità;
ond’io sappia l’essenza dell’immagine

ricondurre alla carne del mio bene:
liquida forma che sulla voragine,
osteggiata e incompiuta è dalla labile
non sondabile e vana vanità
Tutto sia risoluto in tal indagine,
altera d’aver sciolto cura e pene,
nova ricostruendo la compagine
ove soavemente regni Imene.
_______________________________________________
 al confine
al confine
narrare sul filo un confine
che ultimo non è, ma trapassa
nell’ora abolita.
svelata la forma: non è,
riposta nell’ordine basta?
che altro? rincorre,
o s’acqueta in quel filo?
sull’ordine noto che è dato
l’ignoto s’è forse posato
in punta di stilo


L’anima ti darò
 Anima, l’anima ti darò se tu mi guardi
Anima, l’anima ti darò se tu mi guardi
perché riposi in seno al tuo sorriso
il mio girovagare che s’avvolge
costretto come trottola impazzita
***
Anima, s’ànima mia t’intregu si mi càstias,
ca in s’intragna ’e s’arrisu chi scarìngias
si ’nci potzat arrimmai s’andòngiu miu
trottoxèndusi tottu arròlia arròllia,
apretau che bardùfula ammachiada
Galleggiare pallido e assorto

Galleggiare pallido e assorto
dentro la vita col muso storto,
indovinare, qualor le scerpi,
voci intraviste tra siepi e sterpi.
La visione appannata d’una breccia
empie il tuo ventre d’immagini antiche
che si sfilacciano dentro il pensiero
che scivola per erte lubriche.
Rimuginare tra i rami il brancicare
che s’avviluppa tra smanie amare,
mentre s’involano d’aspri crocicchi
le vane ciance d’anime a spicchi.
Poi incespicando nell’avvisaglia
realizzare, nell’intima guerriglia,
come tutto soltanto sia il travaglio
d’interpellare ciò che ti sbaraglia
introverso fra sbarre di bastiglia.
[gennaio 2018]

STIL SEMI-NUOVO
Tanto sgarbata e disonesta pare
la musa mia che a volte mi saluta,
ché d’umore sì spesso ella si muta,
e dunque me ne sto solo a guardare.
Ella vorrebbe, sì, farsi laudare
da me, lubrica d’albagia vestuta,
ma quando alfin ne quaglia la venuta
non si trattiene d’alcunché mostrare.
Tutto in effetti è prendere la mira
giusta a colpire dentro l’heart’s core
che coglier non lo sa chi non ci prova;
e se sillaba sola mi si mova,
io posso dir perfino il fino amore
senza chieder le debba: dai, m’ispira!
M¡Vis* Cagliari, Dicembre 2018
________________________________________________________

 Karalis
Karalis
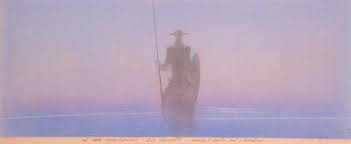
Articoli del Blog
____________________________________________________________________________________
 Ma siete certa, Midons, che il vostro svicolare in allure impostata, astratta e un poco tòpica a voi renda giustizia che il saluto richiede? E che significa, al tròpico tornar di vostra mente, ciò che l’ingegno non illumina di vostra potestà – non fo per vacua laude – intima in voi riposta, sì che ‘l cor pò (e può, sì ribadisco) rendere intera la vostra epifania. L’intrinseco talento, di cui siete maestra, palesate; e, più, voi l’evocate – che dico: revocate – che non sia suggestione, ma il simbolo sapiente che affiori non utopico. Che fu in un meriggiar pallido e assorto, di quelli che frammenti vaghi eccerpi dentro il rimemorar, presso un rovente molo al porto, trasognato, d’estate, fra sterpi inopinati incespicante, del pensar rimuginando (talvolta microscopico inferire). Ecco, io mi rammento, tra portici marini nell’errar caleidoscopico. Non era – sì, ma pur – la lieve veste da voi, qual abito portata, ma quella fiera effigie, carca e onerosa della scienza vostra – a voi ignota in possesso, ed implausibilmente obliterata – che congettura scivolar non lascia dell’enigma vostro (colpo d’ascia), che a vostra costumanza, non mica impermeabile, aderir fate impigliata. Sciarada no, ma a divinatio offerto arcano: durezza ambita ad ogni inconsistenza che mai fin qui quagliò; da promuover difficile lezione. Midons, che voi sapete ch’io non so, diffratta nell’assenza, a me presente. E l’allure si fa passo troppo umano e strugge le certezze, e cedo. Come corpo vivo cade.
Ma siete certa, Midons, che il vostro svicolare in allure impostata, astratta e un poco tòpica a voi renda giustizia che il saluto richiede? E che significa, al tròpico tornar di vostra mente, ciò che l’ingegno non illumina di vostra potestà – non fo per vacua laude – intima in voi riposta, sì che ‘l cor pò (e può, sì ribadisco) rendere intera la vostra epifania. L’intrinseco talento, di cui siete maestra, palesate; e, più, voi l’evocate – che dico: revocate – che non sia suggestione, ma il simbolo sapiente che affiori non utopico. Che fu in un meriggiar pallido e assorto, di quelli che frammenti vaghi eccerpi dentro il rimemorar, presso un rovente molo al porto, trasognato, d’estate, fra sterpi inopinati incespicante, del pensar rimuginando (talvolta microscopico inferire). Ecco, io mi rammento, tra portici marini nell’errar caleidoscopico. Non era – sì, ma pur – la lieve veste da voi, qual abito portata, ma quella fiera effigie, carca e onerosa della scienza vostra – a voi ignota in possesso, ed implausibilmente obliterata – che congettura scivolar non lascia dell’enigma vostro (colpo d’ascia), che a vostra costumanza, non mica impermeabile, aderir fate impigliata. Sciarada no, ma a divinatio offerto arcano: durezza ambita ad ogni inconsistenza che mai fin qui quagliò; da promuover difficile lezione. Midons, che voi sapete ch’io non so, diffratta nell’assenza, a me presente. E l’allure si fa passo troppo umano e strugge le certezze, e cedo. Come corpo vivo cade.

Cagliari: Sa Duchessa, fine secolo XIX.
Tènimi frimma a is bratzusu, fai in pressi,
a lettu tuu cravaminci cruxada;
carignami sa facci, a cunfort’essi,
sùpprimi e codhamì a sa fidada.

Fa’ presto, immobilizzami le braccia, crocefiggimi, inchiodami al tuo letto; consolami, accarezzami la faccia; scopami quando meno me l’aspetto. Patrizia Valduga © Einaudi
________________________________________________________________________________________________________________
*

 La lingua batte dove il dente duole. Riflessioni sul nodo lingua-nazione in Sardegna di maurizio virdis
La lingua batte dove il dente duole. Riflessioni sul nodo lingua-nazione in Sardegna di maurizio virdis
Riflettere sul nesso lingua/nazione può parere cosa ovvia, di fatto scontata. Nel senso comune odierno europeo le due entità vanno più o meno di pari passo, almeno in molti stati europei: l’una si identifica e corrisponde/corrisponderebbe all’altra. Ma, è ben noto, le eccezioni sono più d’una; e la stessa idea di ‘nazione’, ha ed ha avuto, di volta in volta e di caso in caso, fondamenti ideali o concreti diversi: sì che la lingua, intesa come uno dei fattori fondamentali e costitutivi della nazione, è (stata) spesso un qualcosa che motiva e giustifica a posteriori ciò che antecedentemente è già costituito o si vuol costituire. L’idea di nazione – fatto, abbastanza recente, della modernità, anzi uno dei dati costitutivi della stessa modernità politico istituzionale europea – si trasforma poi, nella concretezza politica, come un dato che, a complicare le cose, si intreccia non solo con l’idea, ma anche con la prassi dello/degli stato/i e del loro reggimento istituzionale.
Sappiamo che fattori come la lingua, la letteratura, le sacre memorie storiche (un po’ meno invero quelle demologiche: ma anche qui bisognerebbe distinguere caso da caso), i condivisi orizzonti d’attesa e quant’altro sono andati via via assumendo il ruolo e la funzione di ciò che, innanzi la modernità, veniva assunto e ricoperto dalla religione e dalla religiosità tradizionali: sempre più confinate – nello stato “laico” moderno – entro la sfera dell’intimità soggettiva e personale. Ma, in tale processo, la modernità ha ereditato dalla religione molti atteggiamenti e strutture di comportamento psicosociale, oltre che tanta forma mentis: non ultima quella del conformismo.
Anche la Sardegna si è inserita in tale processo: di volta in volta secondo le determinazioni e le declinazioni che i tempi proponevano, e nei limiti in cui la propria parabola storica l’ha ridotta e condizionata, ma anche con l’originalità della sua, ancora una volta storica e ancor più geopolitica, situazione. Fino all’età e ai giorni attuali e a noi prossimi.
Mi limito giusto a ricordare – poiché non ho qui intenzione di tracciare alcun quadro neppure sunteggiato della storia della lingua sarda – che in epoca medievale la lingua sarda era impiegata nella sfera giuridica e nella produzione documentaria e amministrativa. La cosa è da tener bene a mente se si vogliono comprendere molti degli atteggiamenti e dei riflessi dell’età moderna e contemporanea, insieme alla storia della Sardegna e della sua condizione statuale: basterà ricordare che i viaggiatori e gli osservatori catalani in Sardegna registravano certo l’uso ed anzi il buon uso della lingua catalana in Sardegna, soprattutto negli ambienti e nei ceti nobiliari ed urbani, tuttavia non mancavano di osservare come nell’Isola esistesse e si parlasse l’antica lingua del Regno, e che questa era conosciuta e impiegata da praticamente tutta la popolazione. Per esempio, il Despuig ci dice che, nel 1557, in Sardegna si parla la llengua antigua del regne, dando così al Sardo una certa qual patente di dignità e di importanza. Nel 1565 il Parlamento riunito dal viceré Àlvaro de Madrigal chiede che gli statuti di Iglesias e di Bosa, ancora redatti solo in Italiano, vengano tradotti in una lingua del Regno, ossia in Sardo o in Catalano, e riconosce così una implicita dignità al Sardo, anche se poi la scelta si orienterà, ovviamente, in direzione catalana. Infine è ancora da ricordare che nel secolo alla fine XVI si pose la questione di quale dovesse essere la lingua veicolare dell’insegnamento superiore in Sardegna, il Sardo o lo Spagnolo, con successiva ed anche qui ovvia opzione per lo Spagnolo. Né va dimenticato che in Sardo è scritta e letta la Carta de Logu, legge di principale riferimento dei Sardi, e la cui vigenza si protrarrà fino ai primi decenni del secolo XIX, quando sarà sostituita, nel 1827, dal Codice feliciano.
Né andrà dimenticata in proposito la considerazione che ebbe Antonio Ludovico Muratori riguardo alla esperienza storico-linguistica della Sardegna medievale:
non credo che si possa dubitare che i Corsi e Sardi prima degl’Italiani cominciassero a valersi della lor lingua volgare negli atti pubblici, o che nei Latini frammischiassero molte voci e forme di dire volgari. Però sull’esempio suddetto anche la lingua volgare Italiana, che fino al secolo XIII era stata solamente in bocca degli uomini, cominciò in quello stesso secolo a farsi vedere ne’ versi de’ poeti, nelle lettere, ne’ libri, e in altre memorie1
Considerazioni e giudizio che saranno uno degli inneschi delle riflessioni linguistiche e dell’operazione di Matteo Maria Madao, ma forniranno poi anche esca e materiale da ardere ai falsari d’Arborea, come vedremo in seguito2.
La questione della lingua si pone con piena coscienza in Sardegna con Gerolamo Araolla, nel fervore, fra il ceto intellettuale sassarese, della (ri?)nascita degli studi nell’Isola e della fondazione dei Collegi e delle Università. L’Araolla fonda e inventa una lingua poetica, sarda, per la Sardegna con un intento dichiarato di porre la lingua sarda sullo stesso piano delle due lingue di grande prestigio che nell’Isola giocavano un ruolo primario: lo Spagnolo, per ovvii motivi politici (oltre che, beninteso, letterari), e l’Italiano per motivi essenzialmente di prestigio letterario, ma anche per contiguità, se così si può dire, geografica, storica, tradizionale e culturale; e non sarà da trascurare poi il fatto che in questo confronto emulativo non prenda parte il Catalano, lingua politica e amministrativa, ma dal prestigio culturale e letterario inferiore alle altre due.
L’operazione portata avanti dall’Araolla non aveva intenti politici, né, ancor meno, si deve pensare ad una prima manifestazione di sentimenti o idee-ideologie identitarie, proto-nazionali. L’Araolla ha intenti eminentemente letterari e culturali, legati semmai al ceto, alla classe sociale cui appartiene e alla sua collocazione geopolitica: si trattava di una rivendicazione, da parte del ceto della piccola nobiltà colta, innestata sull’assunto che la cultura era una maniera di conquistare un posto di un qualche rilievo nella considerazione sociale, specie nel periodo della riforma cattolica postridentina, e di conquistarlo in quanto proprio appartenenti ad un Regno, il Regno di Sardegna, che faceva parte della costellazione dei regni dell’impero iberico, con le sue specificità. E ciò forse con un senso già di “appartenenza”, anche se non certo, ancora, “identitario”, il che non poteva essere a quella altezza cronologica. Il tutto poi in una situazione di (ri?)sveglio culturale della Sardegna, che in questo secolo viene maturando una coscienza di sé, storica e culturale, la quale comincia – modernamente, sia pur con tutti i limiti della sua plurivoca angustia – a dotarsi degli strumenti necessari al fine: i Collegi, le Università, le prime biblioteche, la ricerca storico-geografica, la riflessione giuridica; strumenti che mettono in campo in maniera riflessa un’entità politica, istituzionale e culturale quale era il Regnum Sardiniae: soggetto appunto istituzionale, storico e giuridico; e, last but not least, entra appunto in tale gioco anche la lingua-letteratura3. Nel mettere in atto questo tentativo, l’Araolla si rifà a modelli letterari di prestigio e riporta la sua scrittura poetica, sarda, al petrarchismo (declinato a lo divino) della sua attualità cinquecentesca, o meglio immette il petrarchismo dentro la lingua sarda, con un surplus di innesti tassiani, secondo la “moda”. E “arricchisce” la lingua di un lessico poetico di derivazione eminentemente italiana, oltre che, ma in minor misura, castigliana: raddoppiando così la diglossia, cioè creando un registro poetico, sardo, alto e donandolo alla Sardegna.
Andrà comunque osservato che l’Araolla, nella dedica ad Alonso de Lorca, archiepiscopu turritanu, che egli prepone all’edizione del 1582 – e che non sarà poi più presente nella seconda edizione del 1615 – del poemetto in ottave da lui composto, Sa vida, su martiriu, et morte dessos gloriosos martires Gavinu, Brothu et Gianuari, fa uso e stringe in nesso le parole ‘lingua’ e ‘nazione’:
Semper happisi desiggiu Illustrissimu Segnore, de magnificare, & arrichire sa limba nostra sarda ; dessa matessi manera qui sa naturale insoro tottu sas naciones dessu mundu hant magnificadu et arrichidu ; comête est de vider peri sos curiosos de cudda.4
Intendendo esservi una “naturalità” della lingua propria delle diverse “nazioni”, così come v’è la “lingua naturale” della ‘nazione sarda’, espressione, quest’ultima, non usata ma ben sottintesa. Nel seguito di tale discorso, il poeta afferma che pur non mancando la Sardegna di «sutiles & elevados ingegnos in ogni professione», tali ingegni si sono tuttavia sempre espressi in altre lingue e hanno trascurato la propria, cosicché «tanta injuria assa materna limba fetesint»; per la qual cosa, dato che essi hanno impiegato «limbas foristeras», “non naturali”, pur di alto pregio e prestigio, «corrimus [noi Sardi] dare lughe assu sole», cioè ad esprimerci tramite lingue che già sono state elevate «in su colmu» per opera de «sos naturales» di queste, mentre la nostra lingua è pertanto rimasta «impolida e ruggia» per la loro negligenza. Dunque il proposito dell’Araolla è quello di render servizio alla lingua sarda, per mezzo di un lavoro che possa «affinarela, & arrichirela de robas non disconvenientes a issa». L’Araolla è inoltre ben cosciente della valenza pionieristica di quest’opera sua: infatti agli intellettuali sardi dovranno servire «custos sudores mios per primos instruhimentos a simigiansa de sa cuna assos qui nasaquint» [sottolineatura mia]. Siamo dunque, e con piena coscienza, agli incunaboli della lingua sarda, intesa come lingua di cultura, e – se volessimo dirlo con un tantino di forzatura anacronistica, ma neppure poi tanto, giusta la citazione dal Nostro – “nazionale”5.

Tentativo abortito, s’è detto, questo dell’Araolla. E artificioso artificiale. Un giudizio su ciò, sullo ‘sperimentalismo’ araolliano, credo che necessiti però di pacata riflessione, di lungimiranza e di una fuoriuscita da schemi di ragionamento logori. Certamente dopo l’Araolla non decolla una tradizione letteraria in lingua sarda, almeno non in modo massiccio; non si forma un milieu culturale letterario sardo che in Sardo si esprima. Il tentativo, l’esperimento appare essere rimasto lì al palo: la prova generosa di un intellettuale solitario e sognatore. E tuttavia, se si guardano le cose con altra ottica che non sia soltanto quella della tradizione letteraria assestata e canonizzata, se teniamo conto e gettiamo lo sguardo su una produzione, orale e scritta, poetica di Sardegna, se teniamo nella giusta considerazione gli improvvisatori che ancor oggi fanno poesia in Sardegna, ci accorgeremmo che quel tentativo i suoi frutti li ha dati, che quel registro poetico linguistico, in alcuni casi fin oggi ancora, ha continuato ad essere impiegato e a fungere da riferimento quale un polo diglottico alto del poetare – in limba – isolano. Il fatto è che questi frutti sono restati e restano sottotraccia, rispetto ad una valutazione che oblitera tutto ciò che non fa macchia entro la tela dei grandi disegni e récits storico-storiografici.
Quanto poi alla pretesa e biasimata artificiosità del dettato araolliano, non si può non tener conto dei tempi, nei quali un’ampia escursione fra registro parlato e registro scritto letterario, era la norma e la necessità; il riferimento a modelli alti e colti, da imitare per estrinsecare l’originalità dei tempi e dei soggetti, era, esso pure, una forma di pensiero obbligante. Né va dimenticato, in questo “sottotraccia” e in questa nostra obliterazione, il ruolo della predicazione religiosa, rivolta a tutte le classi sociali, che si serve spesso anche del Sardo, e in ciò del suo registro alto, curato e letterario. Se non capiamo ciò non capiremmo neppure perché la variante sardo-logudorese, quella usata ed elaborata dall’Araolla, è stata a lungo considerata la lingua sarda per eccellenza, il “vero” Sardo; e a più riprese: dal Madao e dallo Spano per esempio, per citare i nomi storici più noti di coloro che si sono occupati della questione della lingua; ma questa considerazione è, ancor oggi e tanto spesso, luogo comune nella considerazione popolare diffusa, e in certa misura tale considerazione penetra fin in certa manualistica, pure di pregio extra-sarda.
Si delinea, insomma, già con l’Araolla, una questione annodata che per molti versi resta tuttora irrisolta. La questione di una lingua che deve esprimere una volontà culturale – prima ancora che questa si esprima in termini di identità, e/o di identità nazionale – ma che non trova le condizioni storico-sociali-culturali perché essa si affermi in maniera dispiegata, talvolta però radicandosi nelle coscienze in maniera trasparente, ma talvolta, forse il più delle volte, riemergendo in maniera distorta e alterata, a mo’ di sintomo, dal pozzo del rimosso. Nella dialettica della storia, si potrebbe gramscianamente pensare, è mancato in Sardegna un ceto intellettuale forte e organizzato, tale da poter far coagulare intorno a sé, in senso, anche linguisticamente, sardo, la formazione strutturata della cultura della Sardegna.
E tuttavia, quasi in una contraddizione rispetto al moto iniziale, che era fortemente di classe e accademico, e che comunque operava ai e dai vertici, sia pur ‘provinciali’, si genera una fruizione-produzione letteraria di tipo popolare che quel codice utilizza e recepisce. Fatto che si comprende soltanto se teniamo conto della mediazione e delle necessità ecclesiastiche e religiose, nel cui ambito questa letteratura s’era, a livello alto ma non solo, e in epoca postridentina, avviata e formata: esigenze pastorali e di catechesi primariamente, ma che danno origine a una produzione per molti aspetti autonoma e con seguito produttivo.
Circa due secoli più tardi, negli ultimi decenni del secolo XVIII, Matteo Maria Madao riproponeva con maggior forza e con un senso ed un intento vero e proprio di linguista e filologo, la questione della lingua, della lingua sarda. Non si trattava più soltanto di una volontà cetuale o di un cenacolo culturale quale fu quello sassarese cinquecentesco cui l’Araolla faceva capo; non si trattava più soltanto di letteratura. Si trattava di una riflessione culturale a più ampio raggio, e innestata su prospettive politiche e storiche, nella viva attualità e in un contesto di riformismo illuminista carico delle nuove idee, e che in Sardegna sfocerà nel triennio rivoluzionario e nei moti angioiani, caratterizzati, come noto, da un forte sentimento di appartenenza sarda, fortemente critico – sia pur non nel senso del rigetto e dell’opposizione ideologica precostituita – nei confronti del reggimento politico sabaudo, e facente riferimento alle tradizioni giuridiche sarde.
Le proposizioni del Madao assumono una forte valenza nazionalitaria. Si legga per esempio dall’allocuzione al lettore del Ripulimento del Madao:
La lingua della Sarda nostra nazione, comecché venerabile per la sua antichità, pregevole per l’ottimo fondo de’ suoi dialetti, elegante, per le bellezze che aduna delle altre più nobili, eccellente per la sua analogia colla Greca, e colla Latina, e non solo giovevole, ma eziandio necessaria alla privata, e pubblica società de’ nostri compatrioti, e concittadini, giacque in somma dimenticanza in fino al dì d’oggi, dagli stessi abbandonata come incolta, e dagli stranieri negletta come inutile. […] troppo mi cuoceva, e consumava sul vedere già messo non che in disistima solamente, ma anche in aperto dispregio il natìo linguaggio, , ch’è il più sensibile vincolo del politico corpo de’ nazionali6
E ancora, e più significativamente:
Tra’ Sardi v’ha uno stretto vincolo di società, e un intima unione, che non si può violare. Come la Sardegna è la comun madre de’ Sardi ; così veruno di noi è nato per se solo , ma con l’intrinseca relazione a ciascuno de’ nostri compatriotti; di modo che ogn’individuo diviene a titolo di patriottismo comune a tutti […]. In virtù di questa nostra società, non che tutte le nostre famiglie solamente, ma inoltre tutt’i nostri paesi, villaggi siano , o città formano una comunità di Sarda gente , di tanti cittadini composta , quanto siamo i Sardi, i quali diretti viviamo sotto le stesse leggi da un Sovrano , e tra noi formiamo non solo una intera Sarda nazione , ma anche una sola città, e un sol politico corpo di repubblica […]. Ora di quest’ampia città, e di questo gran corpo di repubblica il più immediato vincolo, e il più a proposito per unire tante membra, e tant’individui, quanti sono i concittadini d’ogn’estrazione, non è altro, dice Tullio, fuorchè la patria lingua de’ medesimi: Propior est ejusdem lingua, qua maxime conjuguntur… Dunque quanto solleciti esser dobbiamo di fomentare, e promuovere lo spirito di politica società tra noi medesimi; altrettanto dobbiam esserlo di coltivar industriosamente la patria lingua Sarda, che n’è il vincolo.7
Ma quale dovrà essere per i Sardi la lingua che li vincola in una nazione, fra le diverse che i Sardi conoscono e impiegano?
Chi non lo sa? L’unica, e sola patria Sarda lingua. […] Né già è solamente la più idonea a mantenere tra’ Sardi il comun tratto familiare in privato, e in pubblico; ma inoltre la più necessaria all’universal esercizio di quelle popolaresche funzioni, proprie del ministero della parola, e de’ sacri ministeri del Santuario. Nel trattare familgiarmente con private persone d’ogni qualità ben ci è permesso l’uso di tutte quelle lingue., ch’essi ponno capire sufficientemente; ma nell’annunziare al popolo, e alto, e basso, maggiormente ne’ villaggi di tutto il Regno, la divina parola colla predicazione, con cui non che pretendesi favellar, e discorrere solamente; ma inoltre perorare, persuadere e muovere e far trionfare la nostra eloquenza in tutti i cuori di quelli, che ci ascoltano; egli si è e sarà sempre indispensabile l’uso di quella lingua, la quale tutti capiscono, e tutti parlano. […]. La delicatezza del volgo in questa parte può dirsi estrema…Il più solido ragionamento, e il più efficace discorso, propostogli in diversa lingua dalla sua propria sarà per lui snervato, ed inefficace; laddove per convincerlo, e per commuoverlo sarà mai sempre un principio di vittoriosa ragione proporglielo in quella lingua, per cui è naturalmente appassionato.8

Il Madao, ben si vede, afferma non soltanto come sia necessario dare una capacità di buona ed elevata scrittura alla lingua sarda, dato che essa, ora negletta e disprezzata, ne ha tutto il potenziale, che potrà rivelarsi al meglio di sé dopo che essa sarà appunto “ripulita” e dopo che sarà ricondotta alle sue proprie, e nobili, origini, che, per il Madao, si troverebbero nel Greco e nel Latino: il Madao afferma e propone il concetto del Sardo quale lingua nazionale, in senso certo ancora settecentesco ma che già prelude ben all’Ottocento e lo anticipa. Infatti se è pur vero che in Sardegna, dice ancora il Madao, gli uomini di cultura e di erudizione ben conoscono le lingue di maggiormente provata tradizione letteraria e culturale, l’italiano in primis, è pur vero che la lingua universalmente intesa in quella che egli chiama repubblica sarda, è proprio e appunto il Sardo; esso però, per la negligenza dei nazionali, è stato trascurato e posto in non cale, e si tratta dunque di esaltarlo e di renderlo degno degli intenti, degli scopi e delle funzioni migliori: di modo che i Sardi, i Sardi tutti, possano intendere i ragionamenti e gli argomenti più elevati non in una lingua loro estranea, ma nella loro: sicché possano meglio comprendere ed essere convinti di ciò che loro si propone. Non solo, ma la lingua sarda, dice più in là, deve avere commercio con le altre lingue per potersi arricchire e affinare, e soprattutto per potersi immettere nel consorzio culturale e di idee degli altri popoli, nazioni e culture (e il paragone è fatto proprio con il commercio, fatto di stampo ben settecentesco quindi: come la Sardegna ha commercio di beni economici con altre nazioni, così deve averlo anche con le parole e i costrutti di altre lingue); ciò non significa allora chiusura dei Sardi nella propria lingua, ma viceversa apertura al mondo, conoscenza delle altre lingue, a cominciare ovviamente dall’Italiano, soprattutto da parte dei dotti e colti: prospettiva di internazionalizzazione se vogliamo dirlo, ma con forte radicamento nella nazionalità sarda: la quale, come ben risulta dalle citazioni sovrastanti, è un fatto di popolo e non di dotti. Vengono dunque tracciate delle linee di politica culturale ben marcata: e non v’è così chi non veda come l’opera e le idee del Madao vadano, in qualche maniera, di pari passo con quanto si agitava e si dibatteva nel contesto politico più strettamente inteso, e non solo sardo. Ma per quanto ci riguarda da vicino, è affermata chiaramente, ma potrei anche dire rivendicata, l’esistenza di una nazione sarda in senso già moderno: nazione il cui vincolo sociale e civile è da ritrovare essenzialmente proprio nella lingua; ed altrettanto è proposta la necessità e la volontà di immettere la cultura sarda nel consorzio culturale internazionale; una tale petizione e rivendicazione della e per la lingua sarda si fonda sul dato delle sue rivendicate e ritrovate nobili origini: e se oggi questa proposizione delle origini nobili della lingua può apparirci speciosa e forse anche un tantino ideologica, tuttavia, non va dimenticato, essa ben si collegava con l’erudizione italiana ed europea del tempo.

La cosa non si ferma qui, quando pensiamo che il Madao aveva già ben chiaro, nei limiti del suo tempo, la storia e la necessità della storia della lingua, delle sue testimonianze documentarie, della necessità di uno standard sovra locale. Se il suo impianto culturale era forse retorico e in qualche misura attardato nell’erudizione, tuttavia il quadro ideologico, e direi pure e meglio scientifico, dentro il quale egli ragiona è certamente moderno, alla pari coi tempi suoi. Una lingua è nazionale non soltanto perché è il vincolo primario della nazione stessa, ma pure è tale se ha una storia, starei per dire se è una storia, e se è capace di elevarsi al di sopra del localismo e delle sue chiusure; se è amalgama nazionale e non limitazione dialettale. Se insomma ha uno standard in cui tutta la nazione può e deve riconoscersi. Tale variante da elevare a standard è ritrovata nel Logudorese in virtù di quella tradizione letteraria, ormai consolidata e di cui sopra si diceva; e pure in virtù del (pre)giudizio, che si vuol però fondare su dati scientifici, che la variante meridionale è mescidata e compromessa dall’apporto di altre lingue con cui è entrata in rapporto. Pregiudizio ideologico che dura tutt’oggi, ben si sa, rafforzato poi certo dal fatto di essere egli stesso, il Madao, logudorese. Ma qui ora tutto ciò ha poco peso, quel che importa sono i cardini principali del suo discorso che per la prima volta, in consonanza coi tempi, stringe chiaramente il nodo che lega, modernamente lingua e nazione: sarda.
Ma i tempi mutarono. Certo in tutta Europa, ma in Sardegna con le sue proprie storiche peculiarità. La Restaurazione nell’Isola arrivò con più di quindici anni d’anticipo, già alla fine del secolo XVIII. Quel vento al cui soffio impetuoso era pretzisu bentulare, s’acquetò. Le cose politiche – e storiche – presero un’altra disposizione, e, volendo dire, si aggrovigliarono. Nel fervido primo cinquantennio del secolo successivo, apparentemente placido, maturarono le idee nuove, ma si ingarbugliarono nodi: la maggior parte dei quali tali son rimasti, grovigli irrisolti. La censura, fin asfissiante, pose più che limiti a iniziative che anche lontanamente potessero apparire ‘rivoluzionarie’ o potessero turbare l’ordine (ri)costituito. Il che non significò tuttavia oblio del recente passato, ma significò ricostituzione e ripensamento di esso, entro il nuovo che si andava incubando. Per la Sardegna ciò significava una duplice idea, talvolta in sé dissociata, di ‘nazione’. Il recupero della memoria storica della patria sarda, (in)tesa verso il riscatto di contro al discredito di cui essa aveva sofferto e soffriva presso la comunità internazionale, e, insieme, la volontà di immissione e partecipazione entro il movimento risorgimentale che andava progettando, con tutti i tentennamenti, le confusioni e le indecisioni, l’unità italiana. Una sorta di moto pendolare fra da una parte l’idea di una herderiana Kulturnation, definita dalla propria lingua e dalla propria cultura, quando non pure dalla discendenza biologica ed etnica; e dall’altra l’idea e la prassi più pragmatica e all’inglese, in qualche modo renaniana, della “nazione elettiva” dove si opera un “plebiscito continuo”: sia pure tutto ciò debba essere pensato come adattato alle specificità storiche e politiche della Sardegna e dell’Italia (in fieri).
Caduta la possibilità e la concreta fattibilità politica di realizzare la ‘nazione sarda’, nasce e si rafforza il “mito” della nazione sarda9: ma da questo mito la lingua, la lingua sarda, sembra prendere le distanze, o comunque stemperarsi rispetto al ragionamento più cosciente e avvertito. Altre ragioni e altre esigenze sembra premessero.
Se ancora nel 1811 Vincenzo R. Porru, nel suo Saggio di Grammatica sul Dialetto sardo meridionale, può ricalcare le orme del Madao (pure citato quale autorità nell’introduzione, L’Autore a chi legge) e parlare di lingua sarda quale lingua nazionale dei Sardi la cui conoscenza è utile alla “Repubblica”, sarda ovviamente; se i presupposti sono ancora quelli del Madao: la lingua sarda ha nobili origini, ha, o può, lavorandovici, avere tutti i mezzi per essere all’altezza di altre ed alte lingue, si tratterà semmai di “ripulirla” e di adeguarla agli assunti migliori; se tutto ciò è dunque nel pensiero del Porru, egli tuttavia immette questo suo lavoro nel proposito pedagogico di un insegnamento e un apprendimento del Sardo al fine di un migliore acquisizione, da parte dei giovani, dell’Italiano, e da qui del Latino. Lingua italiana che è ormai «lingua delle Scuola, della Legge, de’ Magistrati, della Milizia, del Commercio»: lingua dello Stato insomma e dei suoi apparati. Ma, di più, lingua «singolarmente di quella Nazione, cui per posizione geografica noi appartenghiamo». Bella contorsione: frutto dei tempi, parrebbe! I Sardi e la Sardegna sarebbero di per sé nazione col bel vincolo della loro propria lingua, e – tuttavia! – “appartenghiamo”, sì, all’Italia, oltre che come (apparato dello) Stato, anche per “posizione geografica”. Italia (soltanto, nient’altro che) “espressione geografica”? Si starebbe per pesarlo, se la questione non fosse più complessa, e resa pure tale non solo dal fatto che la corona del Regnum Sardiniae – il quale giuridicamente e statualmente è altra cosa dai possessi sabaudi di terraferma – è cinta dal monarca appunto sabaudo che ha scelto come ‘sua’ lingua l’Italiano, ma anche dai recenti e sfortunati eventi del, fallito, triennio rivoluzionario che impongono una spiccata e manifesta lealtà verso la casa regnante e la sua politica. Un affermare smarcandosi, insomma, forse pure sincero, ma intellettualmente imbarazzato e indeciso, fra etnicismo di tipo herderiano e pragmatismo politico. D’altronde in Europa ancora vige la Rivoluzione (in Sardegna peraltro conclusa dalla precoce Restaurazione) e di unità italiana ancora si è lungi dal parlare e dal ragionarvi.
Tuttavia è ben evidente quella dissociazione di cui poco sopra dicevo. La Sardegna è nazione, e l’Italia pure: e la Sardegna all’Italia ‘appartiene’! Una doppia appartenenza, una duplicità che si vorrebbe conciliare.
Tale posizione sarà pure quella di Giovanni Spano, qualche decennio più tardi, anche se con costui la ‘nazionalità’ della lingua sembra mettere la sordina. È pur vero che egli intitola la sua grammatica sarda Ortografia sarda nazionale, ma l’idea di lingua (sarda) come vincolo nazionale (dei Sardi) pare sparire, nessun cenno a ciò nella presentazione al giovinetto alunno. L’esser la Sardegna ‘nazione’, e il Sardo la sua lingua, e ‘nazionale’, è qualcosa che resta implicito, sotteso, perché infatti l’amor patrio traspare in filigrana a varie e più riprese in tutta la sua opera (non solo quella linguistica).
Il fatto è che, come dice Aldo Accardo, nella prima metà dell’Ottocento la Sardegna vive una sorta di «tensione drammatica tra una ostentata e marcata enfasi regionalista fondata sull’affermazione del “valore” e della “virtù” dei sardi, e una convinta adesione al progetto dell’unità nazionale italiana»10. È un periodo fervido per gli studi sardi in Sardegna e da parte dei Sardi, un periodo in cui vedono la luce, tra le altre cose, gli studi e le opere di Giovanni Spano, di cui fra breve diremo, la Storia di Sardegna (1825-27) di Giuseppe Manno, il Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna (1837-38) di Pasquale Tola, la Biografia sarda (1837-38) di Pietro Martini, la Storia letteraria di Sardegna (1843-44) di Giovanni Siotto Pintor, la collaborazione di Vittorio Angius (insieme con Goffredo Casalis) al Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1833-1856), l’opera teorico-politica di Giovan Battista Tuveri. Riguardo a questi intellettuali, Giulio Paulis rileva che essi «non vivevano le due lealtà, quella sarda e quella italiana, come conflittuali e inconciliabili fra loro, ma secondo quanto dimostra il coevo episodio delle false Carte d’Arborea, si sforzavano di conferire prestigio alla propria patria presentandola all’appuntamento dell’unificazione con attestati di nobiltà tali da porla allo stesso livello delle altre regioni italiane di grande tradizione culturale»11. Né va dimenticato che questi intellettuali sono tutti dei liberali moderati, che ricoprivano cariche istituzionali, di maggior o minor rilievo, presso il governo sabaudo, uomini spesso appartenenti al ceto religioso, influenzato dalle idee federaliste del Primato giobertiano. E in tale prospettiva, tendente a un’Italia moderatamente liberale e cristiana, nonché da realizzarsi secondo un disegno federale in cui le diverse componenti regionali trovassero uno spazio di dignità culturale, gli intellettuali sardi potevano vedere il realisticamente possibile e concreto avverarsi delle attese e delle aspirazioni suscitate dai moti di fine Settecento.

Lo Spano, per tornare in argomento, si pone comunque, per quanto riguarda la sua posizione in merito alla lingua sarda, con atteggiamenti ben diversi e meno ingenui rispetto ai suoi predecessori, con una prospettiva più accademica e nazionale (nazionale italiana, dico stavolta) quando non anche internazionale. Egli è maggiormente a contatto, e in corrispondenza epistolare oltre che personale, con il mondo intellettuale italiano e in certa misura europeo, ma allo stesso tempo piantato e radicato in Sardegna e nei suoi uffici e istituti culturali (la Biblioteca universitaria e l’Università di Cagliari soprattutto), mentre i suoi interessi spaziano dalla linguistica (non solo sarda: egli è infatti un buon conoscitore di lingue orientali, con ottimo tirocinio scolastico e accademico extra-isolano), all’archeologia, alla numismatica, alla demologia. Anche in lui una scissione, parrebbe esser presente, ma più trattenuta e meglio gestita: per il tramite del suo magistero scolastico e della sua intensa attività intellettuale che guarda verso e si svolge entro orizzonti meno angusti di quelli isolani. Ma se il suo atteggiamento è accademico e (inter-)nazionale, se il Sardo e la sardità sono per lui l’oggetto di uno studio scientifico, se egli può dirsi il primo dialettologo della Sardegna che compie indagini dialettologiche sul campo, per analizzare la variazione diatopica isolana, sia pure con un atteggiamento che sta a metà fra colui che vuol dettare norme in fatto di lingua e colui che la lingua scientificamente indaga: se dunque tutto ciò pur è, il retroterra culturale ed emotivo dello Spano è ancora quello tradizionale e fortemente radicato nella sua terra, e la sua Ortografia non può che essere ‘sarda nazionale’, come ‘nazionale’ è per lui la produzione poetica orale che andava raccogliendo. E nella prefazione preposta dall’editore al suo Vocabolariu Sardu-Italianu12 viene detto che «lo studio dei Dialetti è lo studio dell’origine delle nazioni, delle oppressioni di che i popoli furono autori o patirono, di loro costumi, virtù, e vizj. La Italia, terra di glorie e di sventure quanto a umano pensiero è dato immaginare, presenta tra le altre nazioni varietà stragrande di Dialetti. […] Tra tanto avvicendarsi di padroni il Popolo Italiano non serbò di suo che i Dialetti, elemento indistruttibile presso ogni nazione, onde poi venne la lingua che l’Alighieri scrisse e le Repubbliche italiane parlarono». Parole significative che testimoniano una posizione mediana e ‘conciliativa’ fra lingua italiana e suoi dialetti, di cui il Sardo, lingua in sé e per sé come lo Spano sempre la definisce, è comunque un “dialetto”, che deve entrar a far parte del mosaico culturale della nuova Italia. Una posizione che se pone i “dialetti”, “elemento indistruttibile presso ogni nazione” all’origine delle nazioni medesime e quindi anche della nazione italiana, vede poi la lingua di Dante esser assunta dalle “Repubbliche italiane”. Da un lato quindi, sembrerebbero stare i ‘dialetti’ quale espressione del popolo (dei popoli?), dall’altro la ‘lingua’, espressione dei colti e dei letterati. Posizione che in qualche modo esprime una contraddizione, a ben vedere, mai sanata in Italia: la quale se ha, in quanto stato, (im)posto l’Italiano quale lingua ufficiale e della cultura (oltre che della retorica nazionalistica), non ha però – messi da parte diversi, frequenti e odiosi eccessi pedagogici antidialettali, e un certo conformismo erudito e/o (piccolo) borghese – mai operato una vera e propria repressione dei dialetti: che anzi il “dialetto”, è stato e ancora viene valutato come espressione viva, genuina e sincera della cultura popolare, benché spesso – ma non sempre per fortuna – folclorizzata. E, soprattutto, i diversi dialetti italiani, magari rinnovati e dialetticamente interagenti con la lingua, vanno riprendendosi, ed anche in Sardegna, il loro spazio pure in sede letteraria, quale manifestazione di ‘verità espressiva’, contro una lingua per letterati: paludata, immobile e ingessata entro la camicia di forza bembesca. E non sarà poi un caso se la prima legge che sancisce chiaramente che la lingua dell’Italia è l’Italiano, è proprio la legge n° 482 del 1999: una legge promulgata centotrentotto anni dopo l’unificazione del Paese! E proprio quella legge che ha come intendimento primario la tutela delle lingue minoritarie, cui riconosce esistenza e diritti!
Dunque, non è poi neppure un caso se, come rileva A.M. Cirese nella sua prefazione alla riedizione delle Canzoni popolari di Sardegna13, raccolte e pubblicate fra il 1863 e il 1872 da Giovanni Spano, i corrispondenti ‘continentali’ di quest’ultimo manifestassero una qualche sorpresa, mista a delusione, nel ricevere il materiale che questi inviava loro. In realtà tali corrispondenti si aspettavano qualcosa di diverso rispetto a ciò che egli inviava e forniva: si attendevano qualcosa di realmente e genuinamente ‘popolare’, forme semplici e leggere, mentre il Canonico trasmetteva componimenti semicolti o addirittura colti e forme poetiche complesse ed elaborate. Ciò a me pare un sintomo particolare della percezione che la Sardegna, tramite i suoi intellettuali, fra XVIII e XIX secolo, aveva di sé. In pratica, come dice ancora il Cirese, gli intellettuali sardi confondevano il concetto di “popolare” con quello di dialettale e di “nazionale sardo”. E ciò, io credo, è dovuto alla particolare evoluzione della cultura sarda, di cui pur brevemente s’è detto sopra: soprattutto quella che in lingua sarda si esprimeva, e per la quale il confine fra popolare e (semi)colto è stato sempre alquanto labile: e proprio per questioni linguistiche, sociolinguistiche e socio-culturali: dato che, si diceva ed è noto, il Sardo ha trovato sempre difficoltà ad autoaffermarsi come registro alto e colto dell’intellighenzia isolana, se non per sprazzi ed illuminazioni episodiche; e se tale registro si è pure affermato, ciò è stato, soprattutto, a livello di poesia orale e ‘popolare’ (con obbligo di virgolette).
La sardità culturale è insomma – per lui, ma soprattutto in lui – qualcosa di fortemente radicato e costitutivo; e sappiamo dalla sua stessa testimonianza, oltre che da testimonianze altrui, quali difficoltà abbia il Nostro attraversato per arrivare ad esprimersi in ‘buon italiano’: ciò che non gli impediva – né lo doveva – l’allargamento degli orizzonti e la compartecipazione della cultura sarda ai processi culturali italiani e finanche europei.

Questa ‘dissociazione’ – di cui parlavo, magari, lo ammetto, con azzardo, e che mi pare essere la cifra di tanta intellettualità isolana fino ai nostri giorni – trovò la sua concretizzazione in un fatto e in una produzione che potremmo chiamare abnorme, ma che tanto fu perversa quanto è, ancor oggi, significativa: si tratta di un’operazione di falsificazione, e fraudolenta, quella, ben ovviamente, delle false Carte d’Arborea, di una produzione cioè di false carte, che i falsari volevano accreditare come risalenti al medioevo e a partire dal secolo IX. La pretesa fraudolenta era quella di mostrare alla comunità intellettuale non solo sarda, ma anzi pure al di là dell’Isola, una Sardegna culla di civiltà letteraria e culturale che anticipava, e di molto, la grandezza dell’Italia medesima; e una Sardegna che in questa pretesa precoce attività faceva uso di entrambe le lingue: il Sardo e l’Italiano. Questa falsificazione, che tenne in scacco l’intellettualità d’Italia e finanche d’Europa per vari decenni (e ci vollero niente di meno che personaggi del calibro di Paul Meyer e di Theodor Mommsen per smontare definitivamente la frode, sebbene in Sardegna non mancarono personaggi, quali il Manno e il Tola, che non cascarono nella trappola, in cui cadde però pure lo Spano)14, questi falsi, dico, la cui confezione aveva a monte ragioni diverse (a cominciare da quella più banale e venale del lucro, ma cui può aggiungersi la frustrazione di oscuri e modesti travet malpagati, per di più in una Sardegna marginale e che non godeva di molta reputazione), furono a loro modo – e proprio nella e per la falsificazione tesa all’imbroglio – un’opera di genio. Chi le confezionò – gli artefici non sono ancora stati identificati con certezza, ma pare più che probabile che il foyer fosse l’Archivio Reale di Cagliari e uno dei falsari Ignazio Pillito – i falsari, dico, centrarono benissimo il loro bersaglio: ossia l’intellettualità isolana, la quale rivendicava, o comunque andava cercando un ruolo di rilievo storico culturale per la Sardegna nel suo passato, nelle sue origini di “nazione” moderna: un passato che si sarebbe collocato sotto il segno, allo stesso tempo, della sardità e dell’italianità. I falsari colmavano ed esaudivano un desiderio, dopo averlo intuito e interpretato; essi furono in qualche modo degli psicanalisti involontari che fecero scattare il transfert della “malattia” sarda: malattia della minorità narcisistica: fra “io-ideale” e “ideale-dell’io”. Ed oggi, a frode da tempo ormai ben smascherata, ci mettono, tutti noi Sardi, davanti a quel blank che ha costituito e ancora costituisce tanta parte, storico culturale, di noi: sul filo di quella ben nota sindrome psicologica, che Nereide Rudas, ha, a suo tempo e proprio a proposito dei falsi d’Arborea, richiamato all’attenzione15; e che consiste nella fantasiosa storia del bambino o adolescente che, marginalizzato e trascurato dalla e nella famiglia in cui si trova a vivere e della quale si sente insoddisfatto, si finge, credendovi, una, per lui, più ‘reale’ e ‘vera’ famiglia, di rango più nobile, alla quale pretende di appartenere. Nel far ciò, i nostri falsari, non solo conoscevano il ‘debole’ dei loro potenziali e, assai spesso, effettivi ‘clienti’, tanto dotti quanto ingenui, essi dovevano pur conoscere la storia della questione culturale linguistica e letteraria sarda, a partire almeno dal Madao e dal Muratori, il quale – lo ricordavo qui sopra – aveva stigmatizzato la precocità dell’impiego del volgare sardo rispetto a quello italiano16: ma a partire da questa, obiettiva, notazione, questi nostri birbanti ed acuti falsificatori vi ricamarono sopra, con acuta e certa intuizione del profondo, e in parte rimosso, desiderio culturale dell’intellettualità sarda, ma pure della specificità culturale della Sardegna. E nei loro modi, truffaldini quanto si voglia, entrarono pienamente, sia pure per via traversa, nel dibattito della questione “sarda nazionale”, se non altro perché la misero davanti allo specchio e ne catalizzarono il transfert.
Ma la storia è andata, l’unità italiana bene o male fu compiuta, (ma non certo in senso federale!): e per la Sardegna con quasi quattordici anni d’anticipo: quel 29 novembre 1847, data in cui, come venne detto, ci addormentammo regno e ci svegliammo provincia, e riguardo alla quale non sappiamo ancor stabilire se realmente «errammo tutti», come ebbe a dire il Siotto Pintor, dapprima sostenitore della “perfetta fusione” con gli stati della terraferma sabauda, poi fortemente critico nei confronti di essa. E intanto il Sardo è trapassato per processo molecolare – per dirla con le parole di Antonio Gramsci, ma rovesciandole forse – all’interno dell’Italiano, modificandolo, e in qualche modo appropriandosene, attraverso un processo che lo svuota dall’interno e lo rigenera in modi propri.
Non so se e quanto siamo guariti da questa stramba malattia della “sarda nazione”. Né se è auspicabile la guarigione: la malattia d’amore è sempre godibile, a patto di mantenerne un lucido cosciente controllo; e il mito è pur sempre salutare e benefico se assunto in dosi omeopatiche. Gli eventi del Novecento europeo, e non solo, tanto spesso tragici per eccesso di nazionalismo, hanno ridimensionato e, starei per dire, disinnescato, specie in Italia, la parola, e fin lo stesso concetto di ‘nazione’; mentre la costruzione politico-economica europea viene poi ridefinendo e ripensando una nuova correlazione Nazione/Stato-Stati, pur, parrebbe, senza di fatto riuscirvi17.
I tempi nuovi ultimi mostrano, soprattutto in Europa, il trionfo (quando pure non è il carnevale) della differenza, della differenzialità diffusa e autoassertiva. L’immaginario politico moderno è segnato «dall’universale affermazione della differenza», di contro a tempi anteriori, ma non lontani, che tendevano «a proclamare l’uguaglianza primordiale degli individui al di là dei caratteri particolari», cosicché «la semplice tolleranza non basta più, anzi prende il volto del disprezzo, perché, secondo i canoni del multiculturalismo, solo il riconoscimento assoluto delle differenze, dell’equivalenza di tutto con tutto dell’assenza di qualsivoglia normalità dovrebbe regolare le relazioni fra individui»18. Questioni ancora contingenti, queste, e all’ordine del giorno nelle agende politiche nazionali e internazionali, fatti e dati ancora propri dell’attualità politica e non ancora passati alla decantazione del discorso storiografico. Questioni in cui spesso, dietro la rivendicazione del diritto alla diversità, si celano pretese e interessi politici d’altro tipo: e ancora una volta Gramsci, verrebbe da dire, ci aveva azzeccato con largo anticipo.
In un quadro politico culturale come questo, la questione linguistica sarda pare non terminata ed anzi riemergente nella sua perennità. Essa rispunta sotto altri termini e modi: l’identità, l’etnicità, il regionalismo, l’autonomismo variamente declinato; la Legge Regionale 26/1997 sulla “promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”; la Carta Europea sulle minoranze linguistico culturali, e la Legge 482/1999, che stabilisce “norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” d’Italia (Sardegna compresa), che recepisce (o almeno lo dovrebbe) il dettato della suddetta Carta europea: nomi, fatti e percorsi nuovi, sul filo di una continuità adattata ai tempi. E si discute se la lingua possa/debba essere parte costitutiva dell’identità, oppure se tale identità debba/possa poggiare su (anche) altri fattori, dando per scontata l’irrecuperabilità di una lingua sarda ormai in estinzione e comunque marginalizzata dalla storia e dalla società moderna. Ed anzi si polemizza sullo stesso concetto di identità: su quanto essa sia (possa/debba essere) ‘spontanea’, o invece ‘costruita’, e elaborata e da elaborare; o anche si dibatte chiedendosi quali debbano essere le dosi della miscela di tali due costituenti, la spontaneità e la costruzione-elaborazione. Ci si chiede se ci si debba considerare un’etnia o una nazione, magari mancata, o magari, ancora, una Kulturnation, che non si sa se, ed eventualmente come debba farsi stato. Ci si chiede quale parte debba giocare, nell’esistenza odierna di soggetto storico-culturale, la specificità antropologica, storica, politica, linguistica; se la lingua sarda debba essere recuperata appieno, per, pienamente, poter essere, e per essere impiegata quale lingua dalla ‘L’ maiuscola, o se essa debba essere un dato di sfondo, un ricordo storico, un dato neo-folclorico, prezioso magari, e da preservare: ma da non, sostanzialmente, usare, se non come retroterra più o meno rimosso o più o meno episodicamente (ri)emergente: come una filigrana nascosta da non esibire, ma da (lasciar) sottendere; tanto più che anche la situazione di diglossia va progressivamente scemando a favore della dilalia e della regionalizzazione, in senso sardo, dell’Italiano.
Né, ancora, va dimenticata – che anzi meriterebbe un discorso a parte che qui non può farsi – la produzione artistica e multimediale in lingua sarda, che ormai raggiunge livelli di elevata qualità: dall’eterna e sempre vivace poesia, alla novità della prosa narrativa, dai nuovi cantautori che si affiancano agli interpreti tradizionali, al cinema, al cabaret, al fumetto, fino alla riscoperta delle produzioni etnomusicologiche e della poesia improvvisata della tradizione. Per non parlare poi, in sede letteraria ma non solo, delle mescidanze e degli ibridismi linguistici e stilistici di tanti narratori e musicisti sardi, che ottengono una notevole attenzione anche, e direi anzi principalmente direi, fuori dei confini isolani: un’attenzione, in casa e fuori, certo maggiore di quanto non ne riscuota la produzione più strettamente in limba, ridotta entro circoli si direbbe underground, e tuttavia attivi e vivaci, che attendono e meriterebbero un riscontro più ampio e più accorto: riscontro impedito sia dalla progressiva perdita della competenza attiva del Sardo, soprattutto nei suoi registri elaborati, ormai pressoché dismessi e dunque scarsamente fruibili, sia da un mercato culturale (e politico) che non ne (vuole/sa) vede(re) il profitto virtuale, né quindi può renderlo attuale.
Ed ancora, par dunque, siamo nella dissociazione perenne, che diventa spesso insoddisfazione, da qualunque parte si guardi la faccenda: perché anche chi ragiona con sguardo ‘cosmopolita’ e guarda alle cose ‘regionali’, anzi, pardon, provinciali…, con una più o meno dichiarata o (mal)celata sufficienza, fa comunque e pur sempre parte della schiera di coloro le cui lingue – così ci disse il Poeta – «a dir di Sardegna non si sentono stanche», fosse pure in un dire negativo, o nell’eloquenza del silenzio.

Perché, infatti, volendola dire in idioma global-internazionale, e giusto per non voler apparire provinciali, the [mother] tongue ever turns to the aching tooth. E se il dente duole, la lingua non può che sbatterci contro.
1 Muratori L. A., Antichità Italiane. Dissertazione XXXII. Dell’origine della lingua italiana,
2 Cfr. Lőrinczi M., La storia della lingua sarda nelle Carte d’Arborea in Le carte d’Arborea. Falsi e falsari nella Sardegna del XIX secolo, a cura di Luciano Marrocu, Cagliari, AM&D Edizioni, 1997, pp. 407-438.
3 Si potrebbe poi anche cominciare a riflettere quale gioco e ruolo possa aver avuto in Sardegna, rispetto al sorgere almeno aurorale di un sentimento identitario e proto nazionale, la lunga guerra contro gli Aragonesi, che si protrasse, con tutti gli annessi, i risvolti e i postumi, per oltre centocinquant’anni, dal terzo decennio del sec. XIV al 1479. Riflessione che potremmo almeno innescare, se teniamo conto di quanto ci dice Hermet G., Histoire des nations et du nationalisme en Europe, Paris, Éditions du Seuil, 1966 (trad. It. Nazione e nazionalismi in Europa, Bologna, il Mulino, 1997. Infatti, dice G. Hermet, è stata spesso l’opposizione bellica contro chi era sentito ‘estraneo’ a generare un primo germe emergente del sentimento nazionale (il caso europeo più emblematico è costituito nell’Iberia, dove i latino-cristiani, gli ‘Spagnoli’ si opponevano agli Arabi); ma anche, soprattutto nel sec. XVI, le rivolte popolari si iscrivono talvolta entro un’idea di appartenenza e di identità politica comuni (cfr. pp. 42-43).

Per quanto riguarda la Sardegna andrebbero indagate le condizioni e la effettiva consistenza ‘popolare’ nella guerra (e/o guerriglia) contro gli Aragonesi; ma anche, specie in epoca più tarda e a conquista avvenuta, le resistenze dei ceti più elevati, urbani e piccolo nobiliari: anche di quelli che, pur di origine iberica, si radicarono e si ‘naturalizzarono’ in Sardegna. Certo poi non è mai da dimenticare l’assetto istituzionale che faceva della Sardegna un Regnum, con le sue istituzioni e i suoi strumenti giuridici e politici:, i quali, come noto, restarono vigenti fino alla “perfetta fusione” del 1847, in piena età sabauda e alla vigilia del compimento dell’unità d’Italia, e invocando i quali il movimento angioiano poté trovare, nello scorcio del sec. XVIII, il suo spazio d’azione e le sue motivazioni rivendicative sociopolitiche.
4 Cito da Araolla G., Sa vida, su martiriu, et morte dessos gloriosos martires Gavinu, Brothu et Gianuari, in CARALIS, Per Franciscu Guarneriu Istampadore de su illustrissimu, & Reverendissimu Don Nivolau Cañellas Episcopu de Bosa, 1582. Riproduco il testo tal quale senza alcun intervento.
5 Tutte le citazioni araolliane qui riportate sono tratte dalla premessa dedicatoria al poemetto sui protomartiri turritani Gavinu Brothu e Gianuari, che si ricordava e citava alla nota precedente.
6 Madao M., Saggio d’un’opera intitolata Il Ripulimento della lingua sarda lavorato sopra la sua analogia colle due matrici lingue, la greca e la latina, Cagliari, Bernardo Titard, Stampatore dell’Illustrissima città, 1782, p. 1
7 Ivi, pp. 24-25.
8 Ivi, p. 26.
9 Sul mito della “nazione sarda” imprescindibile è Accardo A., La nascita del mito della nazione sarda, Cagliari, AM&D Edizioni, 1996.
10 Accardo. A, La nascita del mito della nazione sarda, cit. p.16
11 Paulis G., Prefazione in Giovanni Spano, Vocabolariu Sardu-Italianu, Nuoro, Ilisso, 1998, p. 9.
12 Spano G., Vocabolariu Sardu-Italianu, Cagliari, Tipografia Nazionale, 1851, riedizione Nuoro, Ilisso, 1998.
13 Cirese A. M., Prefazione, in Giovanni Spano, Canzoni popolari di Sardegna, a cura di Salvatore Tola, 4 voll., Nuoro, Ilisso, 1999, Vol I, pp. 11-39
14 Sui “falsi d’Arborea” essenziale è la lettura di Le carte d’Arborea. Falsi e falsari nella Sardegna del XIX secolo, Atti del Convegno di Studi Le Carte d’Arborea – Oristano 22-23 marzo 1996, a cura di Luciano Marrocu, Cagliari AM&D Edizioni, 1997. In particolare, in tale volume, possono vedersi, per le questioni linguistiche, il già citato articolo di Lőrinczi M., La storia della lingua sarda nelle Carte d’Arborea, pp. 407-438; per le questioni letterarie Pirodda G., Cultura letteraria e nazionalismi nell’episodio delle carte d’Arborea, pp.357-382; e Mulas L., Carte “antiche” per la “nuova” Italia, pp.383-405.
15 Rudas N., Le carte d’Arborea come romanzo delle origini, ivi, pp. 505-527.
16 Lőrinczi M.., La storia della lingua sarda nelle Carte d’Arborea, cit.
17 Su questo argomento si vedano le belle e lucide pagine di Hermet G., Nazione e nazionalismi in Europa, cit., pp. 279 sgg.
18 Cfr. Hermet G., Nazione e nazionalismi in Europa, cit., pp. 284.

Mama ’e su celu, sennora de is dis mias, de dogna notti spendia a s’appillai, chi de nocentzia m’alluit su scinitzu sa carri fendu déxida e su spantu, oi, seu preghendi, mi torrint ricchesa, madonna, is fattas mias a s’affainu: chi punnai potzant, chene ’e mudai tinu, a no si ’ndi scorrai macca sabiesa. Un’annu ancora, donna, bortend’esti chi no fatzu capía de su giuali aba m’incrubat gana ’e bosu aresti, drucci chi timu no mi sobri’ e bruxit. A su disinnu chi de amai bos sestu, ammenteisí che mama de sa cruxi! mVis! Cagliari, 8 febbraio 2006.
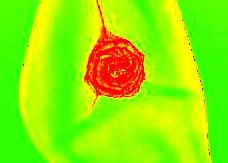
Fior rovescio in cui entra il cor possente e graffia come un’unghia acuminata fin la carne: s’arma l’anima, pur trafitta dalla verga di stupore, col pensier che n’accinghia fin duro zio che sogna nella camera. Fior inverso, alla camera oscura, imago impressa, tosto entra in negativo, mi disarma, e cinghia: tal vecchio zio che m’umilia e m’adunghia. Sì che ribalto, in rifiorita verga, il disarmo d’urgenza che disanima. Capovolto mio fior d’anima armata sol d’un nulla in cui s’incamera il tuo nome, e tua impresa che si verga nel corpo, vi t’infiggi. E assillo m’entra: rimestato dolor in carne d’unghia: trasmette spirto, già ozioso, qual cinghia. Invertito fïor, cinghia d’amor: tu scortichi il disio che s’arma invano e l’anima l’interroga sull’unghia, come l’uggioso zio che in la sua camera gli prova il vizio: e sol timore v’entra, ché freme pur, già teme per sua verga. Fior riverso, secca verga, sbocci che il metro tempri, e zio l’incinghia alla trita ragione che non c’entra: se, inerme, l’alma non l’assista d’arma sua, e ne sancisca il merito alla camerainterna, ove il voler dibatte einunghia Ribaltato fior ch’adunghia il senno, inclito ride se converga umile possa, e risolut’in camera di carità: come un buon zio che cinghia l’anima, e la percuote e avvince e allarma in gaudio, che riscrive il cor che v’entra. Questo fermo voler d’unghia e di zio cinghia mo Bon Respeig con verga ed arma: e l’anima n’incamera se v’entra. E il fior s’inversa. m!Vis* Cagliari, 1 maggio 2011.

Mama ’e su celu, sennora de is dis mias, de dogna notti spendia a s’appillai, chi de nocentzia m’alluit su scinitzu sa carri fendu déxida e su spantu, oi, seu preghendi, mi torrint ricchesa madonna, is fattas mias a s’affainu: chi punnai potzant, chene ’e mudai tinu, a no si ’ndi scorrai macca sabiesa. Un’annu ancora, donna, bortend’esti chi no fatzu capía de su giuali aba m’incrubat gana ’e bosu aresti, drucci chi timu no mi sobri’ e bruxit. A su disinnu chi de amai si sestu, ammenteisí che mama de sa cruxi! mVis! Cagliari, 8 febbraio 2006.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Paxi no agattu e no tengiu ’e fai gherra e timu, e speru; e astrau fogu mi ingollit; e bolu assuba e celu e abarru in terra; su mundu imprassu a nudha ’nd’arregolli. Tentu in presoni ch’issa no aberi’ o serra’, no mi tenit che suu ni latzu sciollit; no mi boccit amori, ni mi scerrat, ni mi bogat de isporu, o bivu m’ollit. Chen’ ogus biu, lingua no téngiu e tzérriu; nendi agitóriu de morti seu abramiu; sprexu mei etotu, e a atra circu gosu. Mi satzu ’e dolu po s’arrisu stérriu; po morti e vida abarru sprexuriu: aici acónciu seu, donna, po bosu. RVF CXXXIV
________________________________________________________________________________
una nuova torre a guardia della civiltà urbana


__________________________-____________________________________________

Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta; mira que sólo te resta, para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. 

Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios, que vive en mí, si no es el perderte a ti 55 para mejor a Él gozarle?
IDEE DI LETTERATURA. Medioevo e dintorni.È cosa ben assodata ormai che, che nel Medioevo, la letteratura aveva una funzione, una ricezione, una maniera di essere percepita: insomma un senso certamente diverso da quello con cui noi oggi individuiamo quella “cosa” che chiamiamo ‘Letteratura’; che anzi ci si può chiedere, come illustri medievisti si son chiesti, se si possa parlare, in termini propri, di una letteratura medievale, almeno per quanto riguarda la produzione in volgare. Tale produzione infatti non ha certo il significato, tutto odierno e moderno-contemporaneo, che consiste da un lato nella manifestazione di una cultura nazionale (o comunque di una cultura peculiare e identificabile, o in cerca di identificazione) e del suo spirito: e non è certo un caso se l’idea che oggi noi abbiamo della letteratura nasca col formarsi, moderno-contemporaneo, a fine Settecento, dell’idea di nazione, congiuntamente con la nozione di lingua nazionale e in prossimità della laicizzazione e secolarizzazione della politica, della società e della loro cultura. D’altro canto è poi difficile dire quale funzione svolgesse la letteratura medievale nella formazione e nella educazione dei suoi fruitori, nella elaborazione del loro gusto estetico e morale; o meglio, resta problematico determinare in quali maniere e in quale cornice semiotica fosse svolta questa funzione. Perché se è vero che tali funzioni erano intrinseche anche alla produzione letteraria del medioevo, questa però non operava nella medesima maniera dei tempi a noi più vicini. E soprattutto quel che è assente in epoca medievale è l’idea della letteratura, e più in genere dell’arte, come espressione del genio soggettivo e originale.
E tuttavia la letteratura medievale resta, proprio per questo, una sfida seducente e fascinosa, perché in essa troviamo, in nuce se non altro, i prodromi della nostra modernità. Troviamo, non dico il travaglio – che sarebbe parola e idea teleologica, oltre che abusata ed insensata – ma troviamo quanto meno uno svolgimento e un processo dinamico che da un lato mostra i germi non deterministici di ciò che sarebbe stata la letteratura nel senso per noi più attuale; mentre dall’altro propone forse possibili e auspicabili soluzioni a ciò che noi oggi chiamiamo più o meno appropriatamente ‘crisi della letteratura’: ci indica una qualche possibile risposta e re-azione alle “notizie dalla crisi”.
Dice H.R. Jauss che la letteratura medievale è prossima, più di quanto non sia oggi (e più che non in epoca antico-classica), alla pragmatica della vita sociale, e che pertanto non esiste nel medioevo il concetto di autonomia dell’arte, ivi compresa quella letteraria1. La produzione letteraria sarebbe dunque funzionale alle ritualità d’ogni tipo, non solo religioso, ma pure sociale; funzionale alla sfera didattico pedagogica, alla dimensione ludica o di intrattenimento. E lo stesso elemento del meraviglioso (come nel lai o nel romanzo arturiano) sta, almeno in prima istanza, in funzione più di una necessità primaria immediata e originaria (per esempio, l’immaginario del desiderio realizzato2) che non di una ‘libera creazione’.

Né va dimenticato l’insegnamento di Paul Zumthor3, e cioè quello relativo alla dimensione eminentemente orale della Letteratura dell’età di mezzo, soprattutto, ma non solo, dal punto della ricezione; infatti la ricezione condiziona ovviamente anche il coté della produzione: e non soltanto come maniera e stile scrittorio, ma anche nella stessa sua semiotica. Lasciando per il momento da parte le Chansons de geste (su cui si tornerà), lo stesso romanzo medievale ci appare più su una dimensione – se posso osare dirlo, e con virgolette d’obbligo – “cinematografica” piuttosto che non ‘letteraria’. Una scrittura narrativa dove l’azione soverchia la meditazione, lo scavo dell’interiorità, la descrizione psicologica o l’analisi sociale. Non che tutto questo sia assente, anzi: e Köhler ben ci insegna. Ma tutto ciò è affidato – dalla parte del ricevente – alla percezione in presa diretta dei comportamenti dei personaggi in scena e della loro azione; le loro motivazioni interiori vengono captate attraverso il loro dialogare o, magari, attraverso il loro monologare, o ancora e ancor più attraverso il loro agire. Come nel romanzo contemporaneo, si dirà; e sì, certo: come nel romanzo post-cinematografico, si potrebbe azzardare. Non è un caso infatti che, insieme a tutto quanto appena detto (e cioè il prevalere dell’azione diretta dei protagonisti e della loro parola), non è un caso, dico, che nell’organizzazione del discorso narrativo, il cosiddetto ‘punto di vista mobile’ rimanga modalità narrativa principale, sotto l’apparente neutralità di una distaccata voce narrante, che mira a catturare, assorbendolo, lo sguardo ‘auricolare’ dell’ascoltatore/‘spettatore’ e a sostituirsi ad esso.
Infanzia del romanzo, aurora dell’arte narrativa? Forse pure. Ma è sostanzialmente un’altra funzione e un’altra modalità di comunicazione del narrato quella che si rivela nel romanzo medievale. Un narrato che deve primariamente intrattenere; e in cui la riflessione, la percezione della problematica, la rappresentazione, tanto spesso raffinata, della psicologia è mediata e veicolata da una rappresentazione immediata in cui il suddetto punto di vista mobile funge quasi da macchina da presa in movimento e incarnata nella voce narrante.
E dunque la scrittura è in funzione di una ‘visione’ suggerita attraverso l’orecchio e la voce. La scrittura è finalizzata alla ricezione e al consumo immediati. Ciò che tuttavia non toglie una funzione anche pedagogico sociale e magari finanche ideologica: penso alla costruzione di un’etica condivisa e orientata verso una soggettività che deve però essere disciplinata, di un’etica coniugale che fa leva sull’idea del cortese amore e sulla edificazione del ‘soggetto nella società’ che deve fondarsi sul (proprio?) desiderio. Ma – e dico nel genere romanzo nel suo complesso, e a prescindere dalla problematica specifica di ogni singolo romanzo – l’aspetto di una produzione destinata al consumo resta. Come può testimoniarci certa produzione, appartenente sempre a tale genere, e che potremmo pure chiamare di tipo (sottogenere?) metaromanzesco, perché tale è a mio avviso. Ma tale ‘scrittura meta-’ non pare certo nascere da una riflessione teorica sulla scrittura e sulla narrazione, anche se ve n’è certa più che l’intuizione. La metanarrazione nasce più che altro come satira che ha di mira l’abuso di consumo ‘letterario’ di romanzo, abuso che genera l’effetto di realtà sul lettore/fruitore. Su un fruitore-spettatore che scambia la rappresentazione romanzesca per realtà e pretende di vivere la propria vita come un romanzo, e/o che agisce atteggiandosi a personaggio di romanzo o si dà pose di amante lirico: e tutto ciò con effetti di umorismo, sottolineato dal controcanto del realismo che vi si giustappone. Penso al Guillaume de Dole, a L’atre périlleux, alla Vengeance Raguidel, al Roman de l’epée, al Bel Inconnu. Una tale produzione metanarrativa nasce insomma dalla consapevolezza di un fenomeno di costume ingenerato dalla letteratura stessa e dal suo consumo, dal riuso e dall’usura più che non dalla valutata considerazione del romanzo come sistema e come funzione autonoma. E se anche tale narrazione ‘meta-’ scopre la letteratura come generatrice di immaginario e di mondi virtuali, tale scoperta non è quella della capacità e del valore autosufficiente della letteratura, ma è la coscienza che la letteratura può distorcere la realtà medesima e indurre in errore se se ne abusa o la si usa in modo errato, e può portare al travisamento del vero scopo che alla letteratura doveva essere assegnato.
Quale sia poi questo scopo non è poi facile dirlo, né la risposta può/deve essere univoca. Ma certo, oltre allo scopo dell’intrattenimento e del consumo ludico di cui si accennava, ve ne è uno pedagogico-ideologico, che è quello, ormai ben risaputo, di creare un immaginario della e per la soggettività, di dar luogo a una rappresentazione del ‘piccolo’ cavaliere che deve essere educato ad una eticità positiva della vita a partire dalla precarietà (del senso) della sua esistenza; ed è inoltre quello di costruire e introiettare nella società medievale, specie quella aristocratica, il senso morale e sociale dell’amore fra coniugi, per una società che deve fondarsi primariamente sulla famiglia nucleare e non più sul lignaggio e sul clan.

Quanto questo scopo fosse forte può essere provato dalla evoluzione del genere epico. Questa produzione più tarda mantiene certo le caratteristiche semiotiche dell’epica, come la strutturazione del testo in lasse, l’uso dalla formularità, la polarizzazione semplice dei valori in gioco, la comunicazione di tali valori attraverso un’evidenza non problematica e senza grovigli narrativi, come invece tanto spesso accade al/nel romanzo, tuttavia l’epica tarda innesta su questa base di ‘genere’ epico, molto materiale ideologico proprio del romanzo, portando in primo piano la coniugalità e acconciando l’azione epica sul cliché dell’avventura, deprivata però della problematicità dell’esistenza, così creando dei veri e propri ‘romanzi familiari’: qui infatti gli eroi generano dei figli, cosa che non capita al romanzo cortese; mentre è la donna a catturare l’uomo, troppo epicamente impegnato nella guerra per poter pensare all’amore, che rimane questione esclusivamente femminile.
Il romanzo mantiene comunque un legame non secondario con la scrittura e inizia, almeno inizia, ad avviarsi nel percorso che porterà all’autonomia della creazione letteraria, nonostante il forte legame che intrattiene ancora con la vocalità e con la ricezione orale; e tale autonomia si genera in quanto il romanzo è legato alla costruzione di mondi virtuali, anche laddove si carica di funzioni didattiche, allegoriche e morali: il romanzo è “vano e piacevole”, si diceva da parte dei chierici, con un mal celato disprezzo, un disprezzo che rivela però il timore e l’incapacità di governare una scrittura e una produzione che loro sfuggiva.
Non così l’epica che è canto del ricordo, della memoria e dell’ emozione; che è storia rivissuta e nuovamente partecipata, riattualizzata nella commozione, nella concezione di un tempo immoto, ciclico e non lineare. All’epica non fa difetto un atteggiamento critico, ma la critica non è il suo senso, né il suo obiettivo primario, né la sua intenzione. L’epica ripropone il passato nella chiave del presente: non però nel senso dell’esemplarità, bensì in quello di una (ri)significazione perenne del fatto storico: di esso non si cercano cause e determinazioni; né nella storia e dalla storia si ricava un insegnamento: nell’epica la storia è un vivaio di riferimenti validi per l’attuale, è l’implicarsi del passato nell’hic et nunc, è l’attualità quale continuazione (e non conseguenza) del passato. La connessione che fa coincidere tempi diversi, il passato e il presente, è attivata per mezzo di una performance che genera il coinvolgimento partecipato dell’audience, per mezzo di un’azione drammatica. Questa la semiosi: ma non mancano all’epica né effetti di fine problematica morale né orientamenti o addirittura propaganda di tipo politico a sostegno di una causa particolare. Problemi peraltro lasciati spesso irrisolti. Anche perché non è volontà di questo genere letterario risolverli: dentro una morale condivisa si affacciano problemi specifici che non mettono però in crisi questa moralità, ma la drammatizzano e allo stesso tempo la esaltano pur nelle contraddizioni che l’esistenza contingente suscita ed implica. È da questa contraddizione che emana il fascino di questa poesia narrativa e la sua originale valenza e dimensione estetica. L’epica è immissione della storia nella vita e della vita nella storia.
Tutto questo in un rituale o in uno psicodramma che aveva funzioni plurime: dallo spirito di crociata alla propaganda politica, dal rinforzo della fede, all’orgoglio di casta, al percorso ‘fantastico’ nell’avventura e nell’azione (anche se non col senso romanzesco). Intrattenimento mirato dunque. L’epica più ancora del romanzo si propone e si fruisce, si ascolta e si recita mediante la rappresentazione e l’azione drammatica, in cui la dimensione narrativa deve condividere, almeno alla pari, il proprio spazio testuale con la dimensione dell’esaltazione e della commozione poetico-lirica: perché in tale commozione partecipativa, la comunità doveva trovare i propri vincoli e il proprio fondamento sociale e morale, che veniva sì problematizzato, ma allo stesso tempo rafforzato e confermato.
Il discorso epico è dunque la riproposizione drammatizzata ed emozionale di quanto è già “storicamente” noto a tutti nella quale l’audience percepisce (o, più tardi, le vien fatto percepire) il proprio principio fondante, mentre l’emittente è il medium di una tale emozione collettiva che genera il transfert.
È, tra l’altro, a partire da tali considerazioni che si comprende il prolungarsi di questo genere letterario anche quando il romanzo le faceva concorrenza. Anzi forse quel dato ideologico che il romanzo conteneva e veicolava, pur insieme a istanze d’altro tipo e per altri orizzonti d’attesa – il ‘messaggio’ ideologico romanzesco di una individualità soggettiva fino ad allora assente e di un nuovo modello erotico-familiare – riusciva, credo, ad essere meglio diffuso proprio attraverso il medium epico, che aveva più ampia e immediata capacità di diffusione. Il che generava il fenomeno di ‘commistione’, cui sopra accennavo, fra generi letterari, fra romanzo ed epica, almeno a livello tematico; commistione che per altro stravolgeva la semiotica tipica del romanzo. Si pensi anche, a tal proposito, al ribaltamento dei ruoli tradizionali, come quando Carlo diventa complice dei traditori della schiatta di Gano e da questi corrotto per denaro: maniera di rappresentare il reale e crescente conflitto storico fra nobiltà feudale da un lato e una regalità che si fa, almeno strategicamente, alleata della borghesia mercantile e del denaro che essa produce: che è il medesimo conflitto rappresentato nel romanzo cortese, ma in forme più sfumate e celate, mentre l’epica romanzata lo rappresenta tramite i mezzi e i modi suoi propri: la semplicità e la polarizzazione evidente a priori del positivo e del negativo, la performance drammatizzata.
Ed altre commistioni l’epica ne aveva già realizzato; quanto meno col discorso agiografico: si pensi all’eroe come santo e come vittima sacrificale.

Insomma la dimensione orale, è cosa ormai accertata, è il tratto distintivo primario della “letteratura medievale” e ad essa non ci si può sottrarre: pena non soltanto lo sfuggirci delle sue reali dimensioni e modalità nel generale contesto della cultura dell’età di mezzo, ma pena anche, come tante volte è successo, la non comprensione di singoli testi: penso, per esempio, al Guillaume de Dole e al Guillaume d’Angleterre, per citarne due. Nel primo, il Guillaume de Dole, la non considerazione del coté orale (oltre che di una modalità scrittoria che non conosce la punteggiatura) ha portato al fraintendimento totale di questo romanzo, perché la trasmissione appunto scritta non può tener conto dei tratti della performance, delle cadenze ironiche, dello sguardo ammiccante, del dire a mezza bocca all’ascoltatore scaltrito e scantato, dell’indiretto libero che qui non è soltanto un fatto di stile letterario, ma proprio, appunto e primariamente, una modalità di eseguire la performance. Quanto al Guillaume d’Angleterre, è la commistione dei generi che ha portato alla misinterpretazione, la mistura di l’agiografia e di romanzo: commistione affidata soprattutto all’impasto di differenti vocalità intriso di variazioni. Grado zero della polifonia romanzesca, messa al servizio di una causa politica, a sua volta imperniata su una problematica morale: il riscatto del mercante e la sua immissione in positivo nella società. Dati, tutti questi, che solo un modo tutto moderno di percepire la letteratura sovrapposto e proiettato su quello medievale, poteva disconoscere e non comprendere.

E tuttavia la “letteratura” medievale, questa letteratura immersa nell’oralità, ci è trasmessa per iscritto, e con la scrittura dobbiamo fare i conti. Quindi se è dovere della filologia tener conto di questa dimensione vocale/orale, e tentare quindi di almeno intravedere e di restituire il contesto e la dimensione di una performance a noi schermata e celata dalla e nella scrittura, la filologia con la scrittura non può tuttavia non fare i conti: la scrittura, la trasposizione in scrittura non è solo un medium di trasmissione, una mera trascrizione, non è solo la trasposizione della dinamica mutabilità della voce nella fissità immobile di un codice. È qualcosa di più. Il fatto stesso che un testo orale venga trascritto è indice di valori storico-culturali-letterari che vanno presi in considerazione. Presuppone un programma culturale magari non sempre definito e dettagliato, ma comunque almeno intuito e prefigurato.
I generi minori della letteratura medievale (saga, favola, fiaba, parabola, exemplum, indovinello, proverbio) sono – per citare ancora Jauss4 – forme semplici del discorso esemplare già elaborate letterariamente, ma che ancora non hanno superato la soglia dell’autonomia dell’arte (l’arte della parola naturalmente, l’arte letteraria): per dirla con Jolles, su cui Jauss riflette, tali forme semplici sono arte senza ‘ancora’ essere “opere d’arte”. Hanno cioè una valenza estetica ben chiara e definita, ma non ancora una dimensione ‘monumentale’.5
Questi generi minori, queste ‘forme semplici’ sono formalizzate in maniera tale da rendere «possibile la tematizzazione e l’elaborazione di diverse richieste della realtà, in modo che l’uomo possa prendere sempre più distanza dalle sue sollecitazioni, sottraendosi alle necessità della prassi quotidiana». Affinché questa soglia possa essere superata, affinché si operi insomma il passaggio di tali generi minori nella sfera dell’opera d’arte, è necessaria quella che sempre Jauss chiama secolarizzazione e problematizzazione dei “generi” medievali. Ciò significa che questi generi minori devono prendere le distanze dalla vita pratica e dalla pratica della vita, anche se non devono certo separarsene totalmente.
A partire da queste proposizioni e suggestioni jaussiane, dobbiamo dire che, finché ciò non avviene, finché cioè la parola poetica non si conquista una sfera autonoma di riflessione, finché la parola poetica non acquisisce la coscienza del rapporto fra i mezzi e i modi suoi propri e i mondi che essa stessa genera e che vanno poi a inserirsi nel pensiero e nella vita, finché insomma tutto ciò non è, non si può dire che si abbia una cosciente opera d’arte letteraria. Non che nell’esercizio effettivo della produzione ‘letteraria’ del medioevo non si siano raggiunti dei risultati siffatti, o non si siano costruiti, attraverso la parola, mondi possibili che abbiano influito (e continuino a influire) sul comportamento e sul pensiero degli uomini, o che non si sia avuta coscienza del potere dell’arte; mancava però una sistematizzazione teorica di tutto ciò: il medioevo ha certo una retorica, ma manca di un’estetica speculativa, un’estetica dell’arte quanto meno, un’estetica non solo intuita ma pure riflessa. E mancava pure di una poetica esplicita.
Da qui si comprendono diversi fenomeni e aspetti che caratterizzano in grandissima parte la letteratura medievale: per esempio il fatto che in pratica ogni testo faccia manifestamente riferimento a una fonte: il che significa la ricerca di un’autorità (magari fino alla finzione di essa), di un’autorità che sostenga e giustifichi il discorso letterario; per esempio l’attività di glossa di testi preesistenti o della fonte stessa; o, per esempio ancora l’allegoresi diretta o latentemente disseminata; oppure il riuso e la rielaborazione di materiale tràdito o folclorico, sia nel senso che, ancora una volta, di tale materiale si fa la glossa, sia nel senso che esso viene adattato alle esigenze specifiche della ricezione e del tempo in cui essa vive.
L’artista medievale è allora, tanto spesso, latore, tramite e interprete di una parola altrui. Ma tale attività di traslazione non è mai ancillare rispetto alla parola fonte originaria. Da qui hanno origine quei fenomeni la cui esistenza, fino a non poi tanto tempo fa, nell’errata e fuorviante concezione di un medioevo primitivo ed ingenuo, non si sarebbe neppure sospettata, fenomeni che pertanto sono passati inosservati e hanno generato più di un abbaglio interpretativo e valutativo. Fenomeni che si avvicinano stranamente alla nostra modernità: e che sono non soltanto la metatestualità ma anche la metaletterarietà e lo sperimentalismo formale. Fatto che si può invece spiegare proprio con quello che è il dato basilare e iniziale del procedere dell’attività letteraria, e cioè la procedura di rilettura e di rielaborazione. Negli autori più scaltri e di maggiore e profonda capacità, proprio l’attenzione impiegata nel dover rielaborare e glossare un testo preesistente, mette in moto la consapevolezza di questa operazione: per cui, più d’una volta, quel che, almeno in filigrana, viene rappresentato è, insieme alla storia o al contenuto del testo, proprio questo processo di (ri)costituzione di esso, viene rappresentato proprio l’iter che riattiva un testo precedente secondo le nuove modalità e finalità di ricezione; oppure, assai celatamente ed anche con sottile seduzione, sono dette e rappresentate le “istruzioni per l’uso”, le chiavi di lettura (Marie de France, Chrétien de Troyes).
Il mixing di generi letterari d’altra parte corrisponde anch’esso a una tale prospettiva pragmatica. I modi e i mezzi letterari, e dunque gli stili e i generi, sono strumenti al servizio di una comunicazione che è, di caso in caso, educativa, ideologica, morale, ludica, salvifica, (auto)critica; non vi è alcun progetto di significato intrinseco dell’arte letteraria: è appunto retorica e non poetica; o seppure una poetica può ravvisarsi, essa è intrinseca e non meditata o riflessa. E tuttavia la fusione simultanea di generi costituisce più d’una volta la consapevolezza delle capacità e del potere dell’arte della parola: si veda p. es. il Guillame de Dole, dove l’ironia a spese di un lettore ‘ingenuo’, rappresentato en abyme, non si districa da una ‘realtà’ che è fabbricata dalla rappresentazione medesima attraverso una ambiguità volutamente insoluta: “c’est quoi la rose/ c’est quoi, enfin, cette rose, cette chose? Est ce qu’elle existe, enfin?”. O ancora, nel Bel Inconnu, una analoga voluta irrisoluzione narrativa è al servizio di una coscienza secondo la quale generi letterari diversi creano mondi virtuali diversi soddisfacendo differenti orizzonti d’attesa reciprocamente irriducibili e inconciliabili. Oppure, e al contrario, la mescolanza è il segno e la manifestazione consapevole di uno sperimentalismo non soltanto retorico ma anche sostanziale, come nel Guillaume d’Angleterre, dove la mescolanza di generi corrisponde a un’esigenza concreta di compenetrazione reciproca fra istanze politiche e sociali da un lato e istanze morali dall’altro: e ciò in quanto la revisione dell’idea/ideologia politica del reggimento e dell’ordine statuale delle classi sociali deve fondarsi su di un ordo radicato sulla sacralità, a sua volta esplicitantesi mediante modelli agiografici, per cui il re deve farsi santo senza poter rinunciare ad essere re; perché solo un re santo, fattosi immagine cristologica, può salvare e integrare la razza dannata dei mercanti: i modelli agiografici vengono così ‘deviati’ e adattati in vista di una tale finalità di ideologia politica. O si pensi ancora al Tornoiement Antecrist di Huon de Merry, dove il modello della psycomachia allegorica si impernia sulle istanze più proprie del romanzo, in quanto le attese didascalico-morali intrinseche nell’allegoresi più tradizionale, che in questo testo vengono soddisfatte e saturate, devono, allo stesso tempo, rappresentare quelle esigenze di soggettività, quei problemi esistenziali dell’individuo soggettivo che il romanzo ha sprigionate.
È la lirica provenzale comunque che manifesta ed esprime oggettivamente una maggior consapevolezza delle ragioni di una ‘poetica’. Non è un caso se i capitoli del volume Storia delle poetiche occidentali6 dedicati al medioevo trattano o delle testimonianze prodotte in latino e della produzione della latinità medioevale, oppure della produzione lirica di Provenza. È ben noto infatti come alcune delle parole chiave della lirica d’amore occitanica si riferiscono tanto al contenuto morale-erotico quanto alla costruzione poetica, alla ricerca della ‘parola’ che esprima questo contenuto. Penso a termini quali joi e mezura che servono il secondo a definire e a dire il primo, mentre il primo funge da generatore necessitante del secondo: la mezura è la via per poter dire l’ineffabile del joi, dell’entusiasmo della gioia d’amore, mentre quest’ultima cerca a sua volta una parola a sua misura. E d’altronde conosciamo ben tutti le canzoni Farai un vers de dreit nient di Guglielmo IX di Poitiers e Escutaz mas no say que s’es di Raimbaut d’Aurenga, dove la creatività e, diciamo pure, la ‘ispirazione’ stessa sono fatte oggetto di canto e soggetto di canzone. Tutto ciò senza che vengano meno le caratteristiche essenziali della letterarietà medievale: quali innanzitutto la ricezione per la via dell’oralità/auralità, e dunque la messa in scena del testo poetico, corredato e sottolineato dalla musica; il tono più o meno marcato di psicodramma; il formalismo lavorato sulla e con la variazione in un virtuosismo non certo sterile ma generatore di forme semantiche e retoriche; i la gara e il dialogo reciproco e a rimando fra poeti; le allusioni, anch’esse reciproche, che generano un dibattito interno offerto alla ricezione, insieme col testo, un dibattito a cui gli ascoltatori sono chiamati più o meno implicitamente a partecipare.
«La performance lirica – dice M.L. Meneghetti – viene dunque a caratterizzarsi come il momento di un rito fra uguali, un rito, cioè, nel quale tutti i partecipanti sentono di essere protagonisti allo stesso modo e con gli stessi “diritti” all’illusione che il canto d’amore genera col suo potere evocativo», in una sorta di Io collettivo che converge in una esperienza compartita. Una ritualità che trarrebbe origine «nel rito magico primitivo, che riflette una situazione socio-economica indifferenziata»7. Questa identificazione collettiva avviene per mezzo di una performance di tipo ‘teatrale’ – dice ancora la Meneghetti – sia pure senza scena o travestimenti, in cui «il vissuto (l’atto sociale) si confonde con l’atto rappresentato (l’atto figurativo), dal momento che l’attore – talora, magari, l’autore-attore – altri non è che uno dei membri della corte e il luogo della rappresentazione è la stessa sala in cui si svolgono tutte le manifestazioni fondamentali della vita nobiliare associata»8.
Per cui non è il testo singolo che conta, né il canzoniere che ancora non esiste, ma l’in fieri di un dibattito sempre rinnovato ad ogni performance, e che rigenera lo stimolo alla presa di posizione. Ogni performance è una provocazione e una sfida che rilancia la risposta e il lavorio poetico in un fermento inquieto. Sfida e provocazione già intrinseca a quello che può dirsi l’enzima stesso di questa poesia e che consiste nel paradosso: la vera forma a-priori che plasma e nutre il trobar. Paradosso che non è solo quel più che noto paradosso erotico-cortese per cui si nega la soddisfazione relativamente a ciò che più si afferma di desiderare, ma un paradosso che anche traspone nella metafora feudale, irrealizzabile nella sua essenza, un fatto che non è sociale ma che è un dato intimo e soggettivo, come è infatti l’amore e il desiderio; parimenti però denunciando, almeno implicitamente, questa metaforica trasposizione come impossibile. E paradosso è anche la trasposizione in lingua profana di un ineffabile mistico religioso: quest’ultimo già ribaltato nel profano della poesia goliardica, viene riportato, senza cessare di essere profano, alla sua radice di provenienza, al punto di partenza, alla mistica così rivisitata e ripercorsa. Capovolgimento che si acquieterà infine e pienamente nella Beatrice dantesca, ma che per ora ama restare sul bilico dell’assurdità e dell’esibita incongruenza: ciò che ha una efficacia non da poco per uno spettacolo da offrire a corte per la corte: alla quale si domanda e si sollecita un/il transfert, per il tramite di una provocata e provocatoria vertigine.
Tutto ciò può dirci qualcosa sulla modernità e sulla odierna crisi della letteratura, ammesso che poi vi sia veramente questa crisi: ma comunque se ne parla. Sembrerebbe comunque certo che la letteratura abbia oggi perso quel ruolo centrale nella educazione al gusto estetico e alla sensibilità linguistica nei confronti dello stile o addirittura della grammatica stessa, nella formazione del senso morale, del senso nazionale; nella costruzione della soggettività e del giusto ed equilibrato rapporto fra io e mondo. Sembrerebbe insomma che la letteratura abbia, più in generale, perso quel ruolo di accesso all’esperienza: come infatti dice C. Ginzburg, a partire dal XVIII secolo «il romanzo fornì alla borghesia un sostituto e una riformulazione dei riti d’iniziazione – ossia, l’accesso all’esperienza in generale»; ma un ruolo altrettanto centrale, potremmo aggiungere, lo aveva, oltre che il romanzo, la poesia lirica, comunque declinata.
Oggi più difficilmente potremmo dire altrettanto, e per diverse ragioni; d’altronde la letteratura è stata negli ultimi decenni oggetto di più di una contestazione, riguardo al suo diritto a una tale pretesa centralità. In primo luogo potremmo metterci la crisi del paradigma pedagogico nella sua totalità; e, in parte legato ad esso, soprattutto come causa o concausa, il fatto che la letteratura si trova concorrenziata da altri media e da altre semiotiche. Da più di ottant’anni il cinema le ha fatto una spietata concorrenza nel suo ruolo educativo-formativo, suggendo da lei molti succhi e molti generi: dall’epica al romanzo, dall’analisi psicologico soggettiva, o a quella sociale e politica. Un cinema nondimeno anch’esso oggi in crisi, a vantaggio della televisione e dei suoi svariati generi e sottogeneri nonché delle sue semiotiche, che si fanno carico di molte di quelle funzioni sociali e perfino – si scandalizzi pure chi vuole – di quelle funzioni pedagogiche che già furono della letteratura e della cinematografia. E d’altra parte la lirica nelle sue svariate dimensioni trova oggi residenza, se rivolta a un pubblico non più elitario, nella produzione musicale e cantautoriale, che ristabilisce il sinolo interrotto poesia-musica, cui oggi si aggiunge anche l’immagine in movimento dei videoclip, e che, sia pure in modi e in contesti storico culturali assai diversi, se non altro perché si trova di fronte a un audience di massa e non più a un’elite di corte, riproduce almeno alcuni di quei fenomeni che già furono della lirica medievale: la performance, lo psicodramma collettivo, la provocazione che lo genera, la citazione indiretta, l’istrionismo: fenomeni mai invero venuti meno, ma rigettati e emarginati e quindi tenuti celati nel ghetto del folclore o della cultura popolare. Una produzione che comunque giunge, nei casi migliori almeno, a risultati che una filologia e una semiotica letteraria non potranno ignorare a lungo. Comunque, a mio avviso, sarebbe oggi impossibile un cinema senza letteratura e una televisione senza cinema e senza letteratura: e non dico letteratura come deposito e tesoro sedimentato nel passato, sia pur prossimo, ma dico la letteratura come attualità e come, magari, militanza; così come sarebbe altrettanto impossibile l’odierna canzone senza la pratica e la produzione rinnovata di una poesia più tradizionalmente e ‘letterariamente’ intesa. E comunque gli scambi fra media diversi, e fra le loro semiotiche, sono salutari per ciascuno di essi, né il meglio di queste produzioni extraletterarie può essere compreso e gustato appieno prescindendo da una previa educazione letteraria.
Ma torniamo allo specifico della letteratura medioevale e alle sue affinità con quella a noi prossima, affinità che dopo Jauss non possono né devono più stupire. Alcune di queste analogie le abbiamo già evocate sopra: lo sperimentalismo, la metaletterarietà, la mescola dei generi, e potremmo aggiungere pure la decostruzione. Tuttavia queste similarità obiettive nascono da input, da stimoli e da molle differenti. Lo sperimentalismo medievale delle letterature volgari nasce dalla necessità di affrancarsi dall’abbraccio troppo costrittivo della letteratura latino medievale e della cultura clericale, affrancamento che non significa tuttavia divorzio, anche se i legami tendono ad allentarsi progressivamente. Ma la necessità medesima di rivolgersi a un pubblico, anche, quando lo è, di alto rango, ma comunque illetterato, indirizza a nuove forme e a nuove maniere di catturare l’audience proprio magari per attualizzare quelle finalità che emanavano dai chierici e per farle recepire dalla ricezione illetterata: si pensi allo slittamento della narrazione agiografica verso la novella o addirittura il romanzo, e alla sua assunzione e assimilazione di materiali folclorici e pagani; o, magari, di movenze e di stilemi epici, se è vero che sono i poemetti agiografici delle origini a modellarsi sul discorso epico e non viceversa. Si pensi alla mistura di epica, folclore e romanzo allorché la ‘purezza’ epica viene superata, nella fruizione, nei tempi nuovi, mentre non viene superata la sua semiotica e il suo ideologema.
D’altra parte gli effetti di metaletterarietà nascono, già lo dicevo, non tanto da una teoresi letteraria e dalla rivendicazione dell’autonomia del letterario, come nella modernità, ma nascono ora dalla necessità effettiva di far comprendere a un lettore, di già bovariano o chisciottesco, l’intervallo frapposto fra letteratura e vita, sì da ricondurlo alla giusta ricezione e fruizione della letteratura e alla sua funzione didattica e morale; ora dalla necessità di far comprendere l’operazione di glossa che l’autore medievale compiva a partire dal testo di partenza. D’altra parte fenomeni che potremmo chiamare di decostruzione (il Guillaume de Dole di Jean Renart, o l’anonimo Atre Périlleux) ubbidiscono certo alla consapevolezza, più che alla rivendicazione, che la letteratura non è imitazione della realtà, ma ha la sua autonomia e i suoi effetti, tuttavia tale decostruire non scavalca i limiti dell’amusant, del ludico, dell’ironia indubbiamente raffinata che mette in burla il credulo lettore, e si risolve in un gioco cortese. Perché seppure il romanzo medievale poteva o almeno voleva essere e fungere, come nella modernità, quale “accesso all’esperienza in generale” o quale rito di iniziazione, poteva anche capitare che il lettore, o meglio il ricettore aurale, fruisse di esso con le categorie dell’epica e dunque dell’immedesimazione emozionale negli eroi: il romanzo insomma anticipava qualcosa per cui il pubblico non era ancora maturo e pronto. Oppure, nel caso della sezione di Galvano del Conte du Graal di Chrétien de Troyes, la decostruzione dell’aventure è la specularità inversa della Bildung dell’eroe e del modello di iter morale che egli deve incarnare: in questo caso la decostruzione è l’oggetto stesso e non il mezzo della rappresentazione, oltre che modalità di un racconto parabola, in cui all’eroe eletto che si costruisce con travaglio si giustappone un eroe negativo che si decostruisce.
Lo sperimentalismo moderno e contemporaneo nasce invece da motivazioni diverse, quali la riflessione sui mezzi, i fini e i modi della letteratura; o quali la coscienza del letterato moderno di essere ormai superfluo in un mondo che ha eretto a paradigma cognitivo la scienza e a finalità pragmatica l’utile economico: donde la chiusura autoriflessiva in sé dell’operare letterario, in una sorta di aristocratico sdegno del letterato che rende intransitiva la sua parola ed elitaria la sua ricezione.

Queste affinità asimmetriche fra medioevo e modernità pongono allora in luce altre asimmetriche affinità; come quelle che corrono fra la produzione letteraria del medioevo, viaggiante sulle onde dell’oralità, e le odierne produzioni ‘a-letterarie’, di cui sopra si diceva, che hanno preso in proprio il potere sull’audience, senza la mediazione, l’autorizzazione o l’imprimatur clericale. Mentre lo sdegnoso ritrarsi del letterato e dell’artista nella torre d’avorio del suo elitarismo neo-clericale, che ha perso però tale potere, genera per reazione la necessità di forme di comunicazione più diretta e più diffusa per le nuove masse neo-illetterate.

Ed allora nuove alleanze sembrano profilarsi e comunque dovrebbero essere concepite, come nel Medioevo, fra chierici e giullari. Perché i nuovi giullari non potranno disconoscere la lettera se vogliono giungere alla soglia dell’essere, mentre i nuovi chierici dovranno pur sporcarsi le mani di oralità e di nuove ‘medialità’, se non vogliono scomparire o restare superflui e residuali. Il coma in cui versa la letteratura non è, io credo, irreversibile. Hablamos con ella! maurizio virdis
1 Cfr. Hans Robert Jauss, Alterität und Modernität der mittelaltlichen Literatur. Gesammelte Aufsätze 1956-1976, München, Wilhelm Fink Verlag, 1977; trad. it Alterità e modernità della Letteratura medievale, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, cap. 7, «Teoria dei generi e letteratura del Medioevo», pp. 218-256.
2 Cfr. ibidem
3 Cfr. Paul Zumthor, La lettre et la voix. De la «littérature» médiévale, Paris, Seuil, 1987 ; trad. it .La lettera e la voce. Sulla «letteratura» medievale, Bologna, il Mulino, 1990.
4 Hans. Robert Jauss, op. cit.
5 André Jolles, Einfache Formen, Halle, 1929, Darmstadt, Niemeyer, 19583
6 Jean Bessière, Eva Kushner, Roland Mortier, Jean Weisgerber, Histoire des poètiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1997 ; trad. it. Storia delle poetiche occidentali, Roma, Meltemi, 2001, segnatamente si veda la Parte seconda «Poetiche del medioevo », sotto la direzione di Danièle Régnier Bohler, e all’interno di essa, il cap. 2 «Trovatori e trovieri» di Marie Françoise Notz, pp. 66-80.
7 Maria Luisa Meneghetti, Il pubblico dei Trovatori, Torino, Einaudi, 1992, pp. 62-63.
8 ibidem

J´ai failli courir vers toi / J´ai failli crier vers toi / C´est à peine si j´ai pu me retenir (…) / Et j´entends siffler ce train / Et j´entends siffler ce train / J´entendrai siffler ce train toute ma vie

Come al contrario splendi, mio fiore inverso. che gioia doni aspra, non amara: al di qua. Dono concesso a armato disincantoamato che non cede. Pur senza principesco non-potere fin oltre il désirer, lì nel pensiero: dirupo ardito, e neve e ghiaccio e gelo. Scudo di vanità alla vanità retrospettiva. In cui radice avvinci allo strapiombo; e sulla pietra.


Sácame de aquesta muerte,
mi Dios, y dame la vida;
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte;
mira que muero por verte,
y vivir sin ti no puedo,
que muero porque no muero.
J’ai pensé qu’il valait mieux / Nous quitter sans un adieu / Je n´aurais pas eu le cœur de te revoir / Mais j´entends siffler le train, Mais j´entends siffler le train, Que c´est triste un train qui siffle dans le soir.

Leggi scritture poetiche
versus (Quo/quo?)
Collegamenti:
Technorati Profile” target=”_blank”>Technorati 
BLOGS-ITALIA.COM Directory Bog Italiani

Des liaisons qui s’avèrent en touchant la façon de l’autre, le visage de l’inconnu, les vagues de l’amour dont on s’aperçoit au touche de l’espoir, au rêve effrité dans un jazz de minuit à la cour d’une vieille maison sans d’autre lumière que celle de l’imagination, par des raisons dont le cœur s’empare par liaison. C’est la joie de l’ennuy : l’apparition du même, de toi, de tous, du tout. Et la désolation t’avère ravi de l’autre, du tout, de tous, de chaque liaison: mais pas de toi, faisant de toi un/l’autre: et tu es l’intimité de ton journal: tu, le blog toi même, ton étrange familiarité, le ruban de l’inutilité de ta beauté qui te joint au vide de ton néant plein de sagesse. Et tu échappes à la trahison de la parole en glissant sur les mots.

psicomatismi (tempus & aliud a un’ipostasi) E basta, shut up, ça suffit: e dai, per ora che ti ridici, ch’è come se strapparsene di nuovo doppiamente e non risulta dimensione esatta: ed io? e allora?sconverge ora cercarti che non torna – né rime né brame né lume: ci sei fra le trame stramate, perché sol mi ricordo che solo ricordo e non sono più qui per stare ancor lì, quant’ore sciupate: non sei. E m’impiglio stentando; rivederci ci provo a lume di viso agognato, figura che oh sì non so come dire mi strugge banale romantico: surplus. Che l’anima perfino vi pretendo, ma tant’è. Non essere allora può essere meglio pur anche scontaaffogare nel gelo tacendo e rimemorando. Pazienza.
E sì, pazienza ci vuole. E di stucco. Che pur lo sapevo, pensarci, che non può se non che svanire, è il clichè: ne resta sbiadito sedimento però, di sentimento e scontento, già ma lasciamo andare, magari come in vasca montaliana – infatti che sai dirmi di nuovo? manco un cenno, o un grumo di semantica o ermeneutica, un appiglio… che ti facesse almeno un po’ semiotica di vita, metafora, che so … – e allora il tacere piuttosto: d’arguzia indurirsi ad accedere a un mancato battesimo cercandovi lo stampo del tuo nome, il fil d’una frase, quella da dirti, sì, che sia al tuo nome il tuo nome, proprio quella: già, è una parola: e certo soltanto una parola sarebbe salvatrice: come noto. E allora, sì, meglio quel vuoto entro cui lavorare, in negativo e sviluppo. Costanza discorde del plasmare l’abuso del previsto – e come a un diario lo dico, vergogna… , …ma ancora (?) – per redimer l’intuizione – primaria – che ti salvi, e moi même, e sia pur presunzione, m’en fiche. Che ti tragga dal brago, e anche me, della replica ennesima, dal tic che ti perde e mi sperde e c’incomunica, scomunica il da dirsi nel ridirsi. Realizzare l’adynaton sarebbe, così, e dunque soltanto scomputare – temendolo, ma certo ex post – il comodo cullarsi nel non dirsi vagheggiando di che star sulla soglia che divide; come e però che l’ho già detto innanzi. Infatti.

Infatti c’è tempo. …il tempo? E certo ch’è il tempo: e va via come ovvio, e sto qui come eterno sulle rughe che scavo a me stesso perverso pur senza vederle, sapendole piuttosto, sapendo che le oblitero, barroso, se scorgo il riflesso che m’agita il viso. E tu? Sì, volerti: tant’ovvio come il tempo medesimo, che sei, sì tu, il tempo che mi segue: e non m’insegue (il tempo fugge e un’ora non s’arresta, ben è vero: ma no, era la vita: un’altra cosa, non il tempo! e di quel che vien dietro a gran giornate, pertanto che ne so? d’altronde me ne frego, e seddiovuole non sei tu), perché tu sei davanti a me che mi precedi infatti, se ti guardo: di fronte a me ti vedo che mi segui, sì: che con me io ti conduco mia ventura e simmetrica compagna d’un passato inesperito, ancora, che il tempo si ripiega puntuale, rovesciandosi nell’abisso azzardato del tuo sguardo, mentre l’anima in te si finge vergine perenne, sospesa al tenue filo d’incompiuta tua parola che possa io colmare, à jamais, con la sua eco, persistita: perché nel tuo fuggire io riscatti, alle tue spalle, l’ombra tua che si sfuma indefinita ed in restituzione me la cucia a te; paradosso eleatico rendendo quel celere pallore innominabile che fa temer gli sciocchi – io tartaruga tua: di te, che col rapido indugio del tuo passo, il tempo mi divori e atteso doni. Sì, ma star fermo di-a-cronico in tal immoto andare – altrimenti è scontato, e d’antan: letteratura – che giova? neppur te ne accorgi, mon âme: che pur se non fuggi, t’eludi:farti sapere? Ma osta l’asimmetria d’orrido interstiziale (il tempo appunto, ancora, o meglio la stagione) che m’occulta: a te, e resta impercepito tutto questo, mentre dovrei giocarlo appercezione, esegesi, esercizio al travaglio che mi/ti (in)formi, dire ‘bene così, anzi meglio!’, lasciandoti al tuo gioco, libertà,hermenêia imprevista. Per schivare il posticipo di ciò che vi precede noioso e prevedibile lagnarsi. Solo così avrai un nome. Per scaricar la vasca dalle some, allora, d’esausto Novecento (dell’ottocento figlio).
D’un tale Novecento a obliterarsi: di ciò ti faccio carico, mon âme, ongle de mon désir, mia désirée incarnita. Lo so che chiedo troppo e son narciso; ma come allor non esserlo? e allora vivi tu e dimmi, e gioca la padrona che saresti se sapessi. E tienimi in iscacco la parola, confondi il mio sapere, turba la dignità della mia mente, grida che non capisco niente: io mi ribellerò, ma tu saresti. Ed io con te. Ma mica per l’angoscia esistenziale, o per quant’altro, giusto per la grammatica lo dico, buttandola un po’ lì sul cognitivo, per provare a capire né essere né tempo, o sainzuntod: che frottole: tu fammi sol sapere quel che voglio: che voglio solo esserci con te, dasain della mia vita. Ma tu però, suscita il meccanismo testuale, mettimelo di traverso fra i coglioni, fra i sentieri interrotti, sì fra quei cippi sulla via dell’abisso; e tienila soltanto un po’ socchiusa, per piacere, l’apertura dell’ente non farci entrare l’aria da demente, solo il niente, se no potrei pensar che son sfigato: fattene un poco tu brava portiera, e prova a conciliare questi estremi, basta congiungerli col filo che saresti se solo ti sfiorasse un nome che t’adorni. Dico ancora. Dimmelo, che sono tutto in un bruscolo di testo, di quello che ti scrivo, se leggessi. Dimmelo che se la falce miete non m’importa, tanto mente, e il tempo a me mi resta tutto quanto intero coagulo per te del mio pensiero da donarti filtrando nel setaccio fitto fitto dei moduli mentali pervicaci il succo ’aideggheriano circostante circonciso per l’essere che fu: che adesso, saltellando fra gli schemi e i concetti, si prova, con plausibile sintassi, a far metafora di te, se ci riesco: oppure falla tu, che è meglio: te ne scongiuro, anima mia, bijou: fallo per me.
Farlo da me è sforzo sovrumano, e sfida tuttavia. Che mi dà un’occasione, ma se lo fossi tu, io dico, sì proprio tu, la metafora che cerco, e insomma la incarnassi, lo volessi…, la incarnissi …… Però potresti dire, ed anche: ma perché? perché non me? perché non io soltanto, quel che sono? e lascia stare, è lungo e ci hai ragione, infine, …… ma però credo che proprio, che l’estasi sia questa: esperirla una metafora in esistere, non dirla, né crearla, o ascoltarla: under my skin averla invece: e avere te, che è meglio d’un lenzuolo che svergogna le nostre nudità da garçonnière (s)coprendole. Ma ti rifiuti che non sai giocare: e sì, bisogna crescere e saperlo; oppure averlo in dono che è ancor più. Dimmi; cioè, che sai? Mica lo sai. Pretendo tuttavia. E non avendo, mi limito in trovate fanfarone, magari pur sublimi, questo sì, talvolta almeno. Per l’effigie di ciò che troverei se fossi l’essere, tu, minuscolo, in spiccioli finanche: ma l’essere che sei, quello che dico, che me lo porto impresso inattingibile, e ce l’hai. Sì, dentro di me. Soltanto.

Soltanto che non fa, manca qualcosa: la fiction dice l’attimo. Ma no, non questo. E manco il feeling, no. No, che non è questione. Va un po’ a cercare, tu: credo sia conoscenza, o meglio l’intuizione della casella vuota da riempire. Quella mancante in me/te, come in amore, appunto. Tu fatti quell’effigie immaginata. Baràttati con essa, se sai dirti: interpreta, traduci. E t’amerò soltanto in quel baratto l’immagine lasciandola al voyeur. Denudati dell’abito consunto: circonda l’ineffabile lacuna col porti qui, davanti a me, sul volto la maschera sublime in cui mi sviso, con cui potrai giocare a far l’attrice che in grazia ed in sua verità va travestita dell’esser tutto quel che io non sono; ti prego che l’essere tu renda in un momento quella finzione là dietro la siepe che il guardo schiude all’ultimo orizzonte. Baràttami, mio amor, col tuo sorriso e che mi perda in un sogno di viso, segno da te indiviso, mia ragione: parola per parola fammi te, tu, nome dell’autrice, proprio lei, la svergognata, sublime ardire del corpo dello spirito, agognata. Che l’essere non sta nella parola (o nel linguaggio) ma sulla soglia angusta del suo farsi corporale, come fiamma d’avvio pentecostale che ci marchia la carne fino al cuore sbugiardati. E parlerò la lingua sconosciuta a me, quella tua propria, dentro cui non stai, che non la langue (né la parole) la volle, e te la insegnerò, tu, carne del mio spirito mancante, tu, spudorata, tu, femmina folle, perché sia anobi ’esser (tuo) quello che sei: tu, dell’inutil vita unico fiore. Tu, che non dici amor che non lo sai. Ed io neppure.
mVis! 25 febbraio 2007.
Articoli del Blog
_________________________________________________________
 Blog_Italiani.net/Blog-Diari-Personali/
Blog_Italiani.net/Blog-Diari-Personali/
 elenco Blog
elenco Blog
blogitaliani


BLOGS-ITALIA.COM: Directory Blog Italiani

We are such stuff as dreams are made on; and our little life is rounded with a sleep.

_________________________________________________________________________________________

























































































































































































































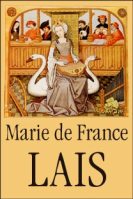






















 Sa pratzidura diatòpica de sa lìngua sarda/La divisione diatopica della lìngua sarda
Sa pratzidura diatòpica de sa lìngua sarda/La divisione diatopica della lìngua sarda











.jpg)











Pingback: 2010 in review | Presnaghe's Blog di Maurizio Virdis
Salude Professore, m’este aggradau meda custu blog. Bos amento sempere cun meda istima. A menzus bìere. Donatella.
Gràtzias, Donatella.
Saludi Professori Virdis, est giai de mada ca seu scruccullendi custu Blog, apu pigau, biu e ligiu tanti cosas interessantis e de arricchimentu, in particulari mi est paxiu meda su chi fustei at iscrittu de s’importantzia de sa scrittura sarda, e no sceti, ma da is personas mannas chi da su passau a nosu prus atesu, omines de grandu cona, cumenti a Gerolamu Arolla, o prus acanta a nosu, Matteu Madau, gesuita e studiosu de grammàtica e retorica de sa metadi de su 1700. Si bireus luegus in sa universidadi a ndi arrexonai. Tengaì contu, Gluca Demontis